Verso il Castello
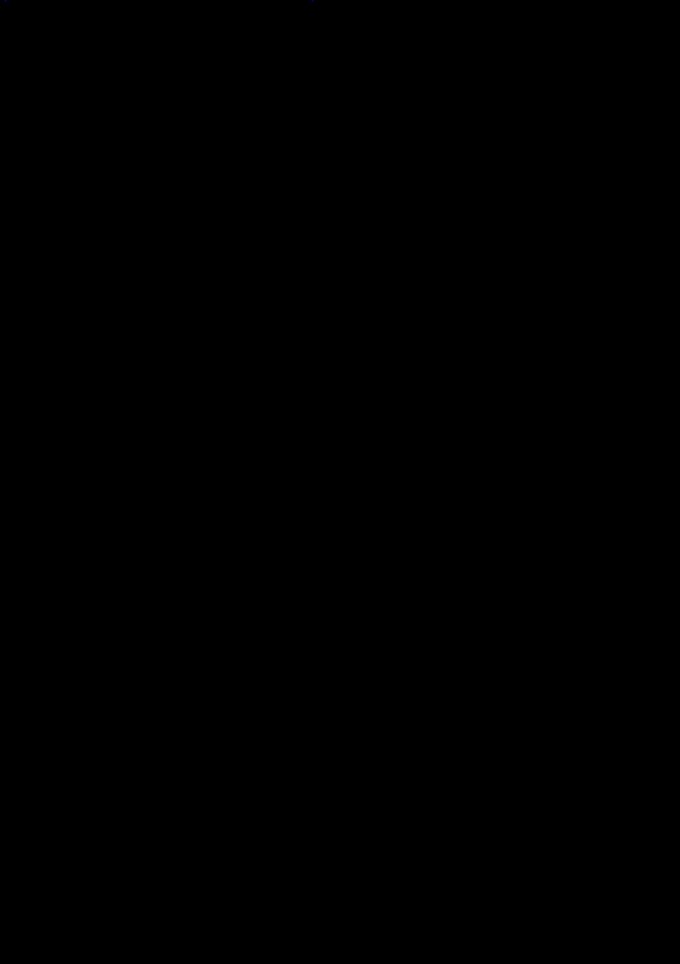
![]() Cosa rappresenta veramente il Castello nell’opera di Kafka, in rapporto al personaggio che non casualmente è denotato con la lettera iniziale del suo cognome K, appunto? Fin dall’incipit il Castello di Kafka ci presenta il protagonista mentre stupefatto tenta di orientarsi nel paesaggio innevato che gli si presenta davanti. I rari oggetti sono confusi e quasi dissolti in una foschia che rende sfuggenti e ombratili i contorni; tutto all’intorno è immerso in un candore niveo: lo sguardo abbagliato dal bianco esteso. Tuttavia l’agrimensore K. sa che quello è il luogo che gli è stato destinato; che a tutti i costi deve restare lì, inoltrarsi all’interno. Prepararsi per una lotta dall’esito incerto. Dal Castello crede gli sia giunta la nomina di agrimensore ed è verso di esso che vuole decisamente incamminarsi. Ma non ci sono veri sentieri.
Cosa rappresenta veramente il Castello nell’opera di Kafka, in rapporto al personaggio che non casualmente è denotato con la lettera iniziale del suo cognome K, appunto? Fin dall’incipit il Castello di Kafka ci presenta il protagonista mentre stupefatto tenta di orientarsi nel paesaggio innevato che gli si presenta davanti. I rari oggetti sono confusi e quasi dissolti in una foschia che rende sfuggenti e ombratili i contorni; tutto all’intorno è immerso in un candore niveo: lo sguardo abbagliato dal bianco esteso. Tuttavia l’agrimensore K. sa che quello è il luogo che gli è stato destinato; che a tutti i costi deve restare lì, inoltrarsi all’interno. Prepararsi per una lotta dall’esito incerto. Dal Castello crede gli sia giunta la nomina di agrimensore ed è verso di esso che vuole decisamente incamminarsi. Ma non ci sono veri sentieri.
Le indicazioni raccolte all’Osteria del Ponte sono vaghe e reticenti; lo stesso messaggero che gli ha recato la conferma dell’incarico è persona poco affidabile come può constatare dal racconto della sorella di lui. Quanto più aumentano gli ostacoli, tanto più cresce l’intenzione di raggiungere il Castello: un edificio per nulla imponente, più un agglomerato di costruzioni quasi casuali, sormontati da una torre, in cui si dice dimori West-west, il signore assoluto del Castello e del villaggio, con i suoi spauriti abitanti. Di quando in quando, un suono attutito di campana, che sembra venire da lontananze estreme. La vera difficoltà che K. incontra e che ogni volta lo spiazza fino a fargli presagire lo scacco, sta nell’accorgersi che in ogni apparente certezza s’infiltra un elemento che ne contraddice i contenuti; questo alla lunga ne strema le difese, fino a corrodere lentamente la fiducia in se stesso e nel progetto che dovrebbe orientare la ricerca. Il principio d’identità e di non contraddizione, i cardini della logica su cui poggiava la propria soggettività, vengono meno, si frantumano nel perdersi indistinto e crepuscolare della pianura, nelle voci contraddittorie che lo dissolvono in una rete di relazioni. Siffatta situazione si ripete ad ogni incontro, in ogni tentativo messo in opera per accedere al Castello. A un soggetto così estenuato continuamente si sottrae ogni riferimento, la direzione giusta del cammino: non resta che la registrazione puntuale, minuziosa, ossessiva dei fatti senza un segno riconoscibile che dia loro connessione. Malgrado tutto, permane tenace la volontà di procedere verso il Castello, che continua ad apparire lontano e confuso, quale luogo di salvezza che custodisce una necessaria verità. Benché smentito, circondato da aiutanti infidi e grotteschi, tradito dalla donna a cui s’era affidato, K. non cancella il desiderio che fin dall’inizio l’assilla, seguitando a valutare ogni cosa e persona in funzione del suo adempimento. Mette in atto strategie complicate e laboriose, che si rivelano ogni volta inefficaci, si sbriciolano vaporando per la penombra diffusa. Ma perché K. vuole con tutte le forze e con ogni mezzo raggiungere il Castello, penetrare al suo interno, stabilire contatti con i signori che lo abitano, comprendere le ragioni di un ordine che con la loro segreta attività mantengono? In parte forse per decifrare i segni di un potere invisibile che tuttavia fa sentire il suo peso sull’intero villaggio? L’ipotesi teologica è quella che è stata per prima avanzata, specialmente dall’affezionato biografo e amico Max Brod: interpretazione che si combina e coesiste con altre, forse più sottilmente penetranti. In ognuna è possibile trovare tuttavia un punto in comune: il potere che tutto pervade e oscuramente si diffonde nel paese e nelle coscienze fino a offuscare ogni senso della realtà e del giusto; il Castello diviene metafora della Grazia e del Potere: nel tortuoso procedere della narrazione è adombrato un essere che oscuramente attrae e si nasconde, disperde le sue tracce nel mondo per rinnovare di continuo il desiderio della ricerca, costringe a indagare le cifre di una possibile presenza; ma il divino in Kafka non possiede affatto le prerogative del Dio della tradizione occidentale e nemmeno di quella giudaica, cui lo scrittore ebreo non rinuncia ad appartenere. In effetti sotto il dominio del Castello e dei suoi signori, si commettono ingiustizie di ogni sorta; i rari segnali di un potere che tutto predispone con una logica cui K. vanamente tenta di opporre alla propria, si smarriscono in una miriade di suoni: una confusa polifonia di voci, che sembrano infantili, stordisce e inquieta, mentre vanno spegnendosi in toni sempre più disarmonici e confusi, che tuttavia misteriosamente affascinano e invitano. È una presenza che continuamente si sottrae, che si manifesta paradossalmente col far avvertire la sua lontananza; i cui criteri di giudizio sono incommensurabili con quelli umani. Ogni idea di provvidenza è scomparsa. E tuttavia da quella zona oscura e luminosa forse scaturisce quella Legge, verso cui tutta l’opera di Kafka è protesa, in una ricerca meticolosa e disperata, condotta nei modi di una prosa che procede piana e distesa, segretamente perentoria, senza impennate retoriche; in uno stile dotato di una impareggiabile essenzialità, secco e preciso nel notare ogni minimo particolare; ma anche venato da un’ironia sapiente e pervasiva, che abilmente modula i toni del racconto. Il mondo allora si presenta come il testo biblico agli antichi cabalisti, quale campo di un’opera di infinita interpretazione, un’attenzione insonne al senso plurimo delle parole, tale da distruggere ed estenuare, differire di continuo le mete, tentare sempre nuove combinazioni, corrispondenze che aprono possibili vie nell’intrico del testo. Nel Castello specialmente questa situazione è pienamente rappresentata, sia pure in forme criptiche e sfuggenti: alla fine dell’opera quando ricorrendo a scaltri sotterfugi K. è finalmente riuscito ad introdursi nell’Albergo dei Signori e a catturare il funzionario Bùrgel che è disposto a parlare, spiegare in qualche modo le procedure che regolano l’attività nel Castello: proprio allora K. è preda di una sonnolenza cui tenta con tutte le forze di resistere. Vorrebbe ad ogni costo ascoltare quella voce monotona che seguita a proferire frasi, forse fare rivelazioni definitive sulle rigide gerarchie nel Castello, sui rapporti col villaggio, sul posto di K. in esso, sulla sua reale situazione, sul destino che gli è assegnato, ma lo vince un sonno più forte di ogni tentativo di veglia. Cade profondamente addormentato mentre l’interlocutore finalmente disponibile seguita a parlare. È questa forse la scena più tragica e insieme più comica del libro, per quella misteriosa corrispondenza di tragico e comico, insita nella condizione umana. Proprio quando è sul punto di acquisire notizie per compiere la sua peregrinazione, di poter udire frasi che rechino indizi su di sé e sul mondo, il soggetto si rivela non essere in grado di sopportare la forza di quello svelarsi. Il sonno sembra proteggere l’esistenza dal potere invasivo d’una rivelazione luminosa all’eccesso e alienante. E allora la parola che forse dischiude aperture nel chiuso mondo della Legge, è destinata a non incontrarsi con l’esigenza di conoscere che pur fortemente persiste nella tensione umana verso un orizzonte di senso che attenui finalmente l’oscuro e profondo sentimento di colpa che grava sul soggetto fin dall’inizio della narrazione (in questo collegandosi al tema del Processo, scritto nel 1915, mentre il Castello fu scritto nel 1922 e mai completato, come del resto il Processo). Come nell’apologo inserito nel Processo, il contadino resta in fidente attesa davanti alla porta della Legge, custodita da terribili guardiani a inibire l’accesso; solo quando è ormai sfinito e moribondo, il contadino s’avvede che la porta viene chiusa: ma ora che la morte s’approssima, non v’è più motivo che la porta resti ancora aperta.





-ban.jpg)















































































































































































Non ci sono commenti, vuoi farlo tu?
Scrivi un commento