Petrarca in Campidoglio
“Coscientemente voluto, pazientemente preparato e sollecitato dallo stesso Petrarca”1, l’episodio dell’incoronazione in Campidoglio è certamente il più spettacolare e simbolico di una vita già molto significativa – malgrado i 37 anni ancora da compiere – quanto a onori, pubblici riconoscimenti e fasti mondani. Secondo la versione ufficiale, “accomodata” e divulgata dal protagonista medesimo, tutto avrebbe inizio l’anno prima. È il mattino del 1° settembre 1340 e Petrarca passeggia per i boschi di Valchiusa, nei pressi di Avignone, quando gli viene recapitata una lettera del senato di Roma, che lo invita nella città eterna per il solenne conferimento dell’alloro poetico (sorta di premio Nobel dell’epoca). Poche ore più tardi lo stesso invito gli giunge dall’università di Parigi. Si legge nell’epistola latina Posteritati: “Soggiornavo in quei luoghi quando – sembra una favola! – mi arrivarono nella medesima giornata due lettere, dal senato di Roma e dalla cancelleria dell’università di Parigi, che a gara m’invitavano a ricevere l’alloro di poeta e a Roma e a Parigi. Ero giovane e me ne inorgoglii, stimandomi anche io meritevole di quell’onore di cui m’avevano giudicato degno uomini sì autorevoli, e dando peso non ai miei meriti ma alle asserzioni altrui”.
Altro che favola! Nulla, in realtà, avviene per caso. Petrarca ha saputo muoversi abilmente per ottenere gli inviti: il primo grazie all’appoggio dei potentissimi Colonna; il secondo grazie all’intercessione del teologo e cancelliere Roberto dei Bardi. Tutto è (quasi sempre) perfetto, in Petrarca: pensato per il giudizio dei posteri, calibrato a somma dignità, predisposto con la massima cura del dettaglio scenografico – nello spazio mentale di un teatro che è foro interiore, che guarda alla “splendida astrazione” della Forma, a un mondo immobile e ideale, mentre procede nelle brume inquiete dell’Ego e si dibatte tra i chiaroscuri dell’anima, senza sciogliere i lacci di una narcisistica e ossessiva autoreferenzialità. Il primo colpo di genio sta nel fare in modo di ricevere gli inviti in contemporanea (ciò che li avvalora a vicenda, li rende ancor più preziosi, evidenti di predestinazione), e dunque porsi in un imbarazzo che è solo fittizio, funzionale alla scena, poiché Petrarca ha già optato, in cuor suo: sa già prima ancora di decidere che andrà a Roma.
“Ero tuttavia esitante a chi dare la preferenza, e per lettera ne chiesi consiglio al cardinale Giovanni Colonna: abitava così vicino che avendogli scritto sul tardi, potei ricevere la risposta il giorno dopo prima delle nove. Seguii il suo consiglio e decisi di preferire la maestà di Roma”.
A questo punto Petrarca, che le pensa tutte in anticipo, ha bisogno di rendere la propria incoronazione immune da eventuali critiche di maligni ed invidiosi. Cosa di meglio che il patrocino di un sovrano di prestigio? Ed ecco il secondo colpo di genio: Roberto d’Angiò.
“Decisi perciò di recarmi prima di tutto a Napoli, e mi presentai a Roberto, grandissimo re e grandissimo filosofo, non meno illustre per la dottrina che per lo scettro: l’unico re che i nostri tempi abbiano avuto amico e del sapere e della virtù. Vi andai perché mi giudicasse secondo il suo parere; ed oggi io mi stupisco – e credo che sapendolo anche tu, lettore, ti meraviglierai – pensando a quale gli sembrai e a come gli fui accetto”.
Prende dunque accordi col re di Napoli per farsi esaminare ed essere giudicato degno, o meno, dell’alloro. Mancano ancora diversi mesi all’incoronazione, ma occorre muoversi per tempo. A una cerimonia così spettacolare, peraltro, non può bastare un prologo qualunque.
Tra la fine del 1340 e l’inizio del 1341, il “laureando” prepara la Collatio laureationis, orazione che pronuncerà nel corso della cerimonia. Lo scritto, che abbonda di citazioni da autori latini del calibro di Virgilio, Ovidio, Stazio, Lucano, Orazio, Cicerone, etc., è in buona sostanza una convinta e appassionata esaltazione della poesia, del suo “intimo impulso” che procede per “intervento divino”, del potere che ha di rendere immortale sia il poeta sia colui o ciò di cui parla – ma è anche un devoto omaggio a chi (come accadeva nella Roma di Augusto) la tiene nel debito conto.
Il 15 febbraio 1341 Petrarca parte da Avignone per Marsiglia e di lì, via mare, per Napoli. Roberto d’Angiò lo accoglie con viva cordialità, grato per l’onore che il poeta gli ha riservato, eleggendolo a suo unico giudice. Seguono giornate di libere conversazioni e passeggiate a cavallo. Il dolcissimo mese di soggiorno napoletano si conclude con l’esame, che dura da mezzogiorno a sera ma – crescendo di continuo la mole degli argomenti affrontati – deve protrarsi per i due giorni successivi. Petrarca, naturalmente, fa un figurone: il re, abbagliato da tanta e tale cultura, non può che dichiararlo solennemente degno del massimo onore poetico.
“Sondata così in tre giorni la mia ignoranza, alla fine del terzo mi proclamò degno dell’alloro. Me l’offriva a Napoli e mi pregava con grande insistenza perché consentissi: l’amore per Roma l’ebbe vinta sulla veneranda insistenza d’un tanto re”.
La cerimonia sarà a Roma o non sarà: il proposito del poeta è “inflessibile”. A Roma Petrarca c’era già stato nel 1336. La maestà delle rovine antiche lo aveva vividamente impressionato, accrescendo in lui la venerazione per il mondo classico già instillatagli dai libri.
Ricorda nella Posteritati: “(…) andai a Roma, che sin dall’infanzia desideravo ardentemente di vedere; a Roma mi affezionai tanto al magnanimo capo della famiglia Colonna, Stefano, uomo della stessa levatura di qualsivoglia degli antichi, e tanto gli fui accetto, che avresti detto non facesse differenza fra me e i suoi figlioli”.
Perché Roma? E dove altrimenti? – verrebbe a tutta prima di rispondere. Dove se non in quella che fu ed è, con il Cicerone della IV Catilinaria citato da Petrarca, “rocca di tutto il mondo”? L’amore che il poeta nutre per Roma equivale alla sua grande ammirazione per l’antichità e al suo desiderio di trasferirsi idealmente in essa. Corrisponde inoltre al suo disprezzo per l’età presente, che gli è “sempre dispiaciuta, tanto che se l’affetto per i miei cari non mi indirizzasse diversamente, sempre avrei preferito d’esser nato in qualunque altra età; e questa mi son sforzato di dimenticarla, sempre inserendomi spiritualmente in altre”.
Roma rappresenta il culmine delle sue inquiete peregrinazioni e il fulcro delle sue aspirazioni ideali. Ama Roma antica perché era favorevole ai poeti e li teneva in “grandissimo onore”, specie sotto Augusto. L’emblema di questo “spirabil aere” resta eternato dalla cerimonia di incoronazione dei poeti in Campidoglio. Il rinnovarsi di tale usanza con Petrarca stesso, dopo secoli di abbandono, sta a significare anzitutto la rinascita della Poesia, nella sua forma più illustre. Non a caso – ennesimo dettaglio scenografico – l’incoronazione è prevista la domenica di Pasqua (8 aprile): ciò che deve risorgere è la poesia classica, in particolar modo epica, grazie al presunto capolavoro dell’Africa (da cui Petrarca attende le glorie maggiori). Egli si propone così come “nuovo Virgilio”, primo nuovo poeta di Roma, dopo mille anni di silenzio: sacerdote di un autentico, fervido culto della poesia quale si era manifestato nella Roma di Augusto e che ora sta risorgendo dalle proprie ceneri.
“Non dunque, o non soltanto, un interesse personale sospingeva Petrarca, ma la convinzione di restituire alla società colta del tempo una cerimonia che fosse il simbolo di una civiltà rinnovata”2.
È già in atto la coscienza storica di uno iato tra la fine del mondo antico, cioè della cultura classica, e gli spregevoli tempi coevi. A questa coscienza si accompagnano le forme di un progressivo ma inesorabile rinnovamento culturale. Poesia colta di filologia e, specularmente, cultura a prevalenza poetica, pittosto che filosofia e teologia di stampo tardo-medievale. Il poderoso sforzo di classificazione e sistemazione concettuale, che mira a dare conto di ogni cosa – per cui il creato rientra in un ordine verticale e perfetto che, partendo e concludendosi nel Creatore, racchiude tutte le sue manifestazioni – cede il passo ad un approccio analitico, particolare, discontinuo, diffidente verso le grandi sintesi e orientato preferibilmente alla contemplazione dell’io, all’autoconoscenza. Da qui il fastidio che Petrarca, primo di tanti, prova verso la filosofia scolastica, di cui ancora Dante era imbevuto. Tanto più significativa e niente affatto casuale è, allora, l’antitesi Parigi vs. Roma – da cui il dilemma che Petrarca scioglie con decisione molto più intima e netta di quanto l’incertezza iniziale lascerebbe supporre. Una scelta che suona con ogni evidenza come un manifesto programmatico di cultura. Le trombe che squillano nel Campidoglio in festa segnano così l’annuncio-spartiacque di una nuova epoca: è l’aurora dell’Umanesimo.
Petrarca, declinato l’invito di Roberto d’Angiò (che lo avrebbe accompagnato a Roma, se l’età avanzata glielo avesse consentito), accetta tuttavia di indossarne un manto nel corso della cerimonia. Roberto invia in sua vece Giovanni Barrili, il quale, preda di un agguato banditesco nei pressi di Anagni, non può giungere in tempo. Petrarca è a Roma dal 6 aprile. L’8, il gran giorno, la sala d’udienza del Palazzo Senatorio in Campidoglio è gremita di nobili in festa.
Ricorda Petrarca nella IV delle Familiari: “La folla, desiderosa di assistere allo spettacolo, si accalca rumoreggiando. Io stesso, se non mi sbaglio, vidi frenare a stento lacrime di tenerezza che salivano dai cuori commossi di tanti amici ivi raccolti. Ascendo. Le trombe tacciono e tutti ammutoliscono. Il sacro nome di Virgilio diede principio alla mia orazione, ma il mio discorso non fu lungo. Non lo consentiva infatti l’usanza dei poeti e non è cosa opportuna violare i costumi delle sacre Muse che io, dopo aver strappato dalla vetta del Parnaso, ho costretto ad abitare per un po’ di tempo nelle città e in mezzo al popolo. Dopo di me prese a parlare Orso dell’Anguillara, oratore facondissimo. Finalmente mi cinse le tempie con l’alloro delfico mentre tutti, attorno a me, applaudivano. Il vecchio Stefano Colonna, il maggiore fra tutti i contemporanei di Roma, fece allora il mio elogio”.
L’ascensione al Campidoglio è complementare a quella del monte Ventoso (aprile 1336), compiuta insieme col fratello Gherardo: emblematiche entrambe, nel loro reciproco rimando, della dialettica che racchiude il “dissidio fondamentale” della personalità petrarchesca. Laddove la prima manifesta al massimo grado il suo desiderio di gloria terrena, di onori, di riconoscimenti (una tra le colpe più gravi esaminate – e rimproverate a Petrarca da S. Agostino – nel terzo libro del Secretum), la seconda porta alla luce il bisogno di una vita più pura e raccolta, tutta indirizzata allo scavo interiore e al perfezionamento spirituale. La grande vanità terrena dell’incoronazione, infatti, fa da preludio, e forse da stura, al culmine di una crisi religiosa già latente da anni, che di lì a poco (scatenata invero dal ritiro monacale del fratello) turberà di rimorsi la già inquieta esistenza del poeta. Petrarca è così: non riesce mai ad aderire in toto, senza provare pentimenti e sensi di colpa, ai valori terreni che pure lo attraggono molto. “Pecca” male, incapace di godere almeno quanto di sopire il desiderio. Francesco Petrarca, o del “peccato infelice”. Non è un caso, ancora una volta, dunque, che – conclusa in trionfo la solenne cerimonia – egli si rechi subito in San Pietro per deporre sull’altare la corona appena ricevuta.
———————
1 Vedi Storia letteratura fotocopie
2 Vita di Petrarca, p. 79

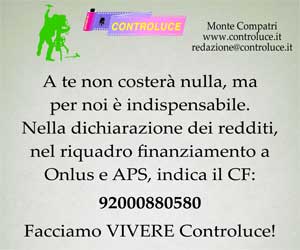



-ban.jpg)















































































































































































Non ci sono commenti, vuoi farlo tu?
Scrivi un commento