Percorsi di pace ..incendiari
 Oggi che le relazioni, i contatti e la conoscenza sono sempre più intrecciati e diffusi attraverso un universo virtuale diventato parte integrante del nostro quotidiano, le percezioni hanno la prevalenza sui fatti.
Oggi che le relazioni, i contatti e la conoscenza sono sempre più intrecciati e diffusi attraverso un universo virtuale diventato parte integrante del nostro quotidiano, le percezioni hanno la prevalenza sui fatti.
Tutti noi siamo ormai abituati a credere più alla notizia che non ai fatti e ai dati oggettivi. Noi italiani, noi europei, noi occidentali (così come nell’accezione comune ci si definisce), riteniamo apparentemente di vivere in un periodo di pace. Eppure nei fatti non lo siamo. Alle porte del nostro occidente il mondo è in fiamme. I nostri stati sovrani sono tutti impegnati in missioni di guerra. Le rivolte e le guerre civili interessano paesi e popoli a noi sempre più vicini. Dalla guerra jugoslava ad oggi il Mediterraneo è divenuto il principale teatro di scontri.
La velocità delle comunicazioni ha reso il nostro pianeta piccolissimo; viviamo tutti in un “non- luogo”. La notizia però non ha più il valore di notifica di un fatto, di inizio di un’indagine di approfondimento. Si indaga solo sull’ipotetico futuro, sugli effetti o sulle conseguenze, ma senza approfondire il passato e il presente. Così anche azioni che hanno un loro nome e cognome assumono significati diversi, se non opposti. Dare il giusto valore alle parole che utilizziamo e usare le parole attinenti ai fatti che descriviamo è necessario per uscire dalle false percezioni e calarsi nel presente, nell’oggettivo. Le nostre istituzioni, nazionali e sovranazionali, così come chi è demandato a fare comunicazione deve necessariamente cercare l’incontro tra esperienza sul campo e creatività letteraria, quando ci comunicano qualcosa. Per governare e spiegare la modernità è necessario attenersi a quella “scrittura antropologica” coniata dal grande antropologo Marc Augé. Così i bombardamenti, avallati dall’Onu, sui cieli della Libia, non possono essere definiti azioni di peace keaping; l’impegno dei nostri eserciti in Iraq e Afghanistan non assolvono ad una missione di pace.
Una larga fetta del popolo libico è in rivolta, ma l’intera nazione è anche artefice di una sanguinosa guerra civile. Noi “occidente” non dobbiamo né esportare democrazia, ma nemmeno interpretare per gli altri le loro richieste di libertà come richiesta del nostro modello democratico. I tanti giovani tunisini e egiziani che hanno agitato le piazze di questa primavera araba che profuma di gelsomino, chiedono principalmente pane e libertà. Le rose devono ancora sfiorire. Questi giovani magrebini non invidiano affatto il nostro modello democratico, che chiude loro le porte. Invidiano la nostra libertà di movimento, di scegliere dove vivere, che noi stessi però precludiamo loro. La loro protesta è rivolta proprio alla politica corrotta, cinica e inefficiente dei governanti dei loro regimi, ma che caratterizza anche le nostre istituzioni europee. Siamo di fronte a rivolte di liberazione. Le nostre libertà, ingabbiate nella struttura democratica, i nostri privilegi, sono altra cosa rispetto alle loro richieste. I nostri percorsi e modelli di pace, che cerchiamo di esportare, sono ormai omologati in qualsiasi parte del mondo. Sono percorsi classisti e globalizzati. Le nostre risoluzioni sono percorsi di pace incendiari.
Se vogliamo veramente aiutare questi popoli in lotta dobbiamo aiutarli verso percorsi di autodeterminazione.
Accettare le loro scelte, i loro modelli, comprendere appieno le loro culture. Dobbiamo anche noi rivoluzionare i nostri modelli comunicativi e di conoscenza. False interpretazioni e definizioni devianti di questi fenomeni, ci allontanano dalla verità. Quanti conoscono la differenza tra sciiti e sunniti? Quanti conoscono i dettami coranici o la storia del sionismo mondiale? Quanti dei nostri giornalisti, politici e analisti conoscono e studiano i popoli in lotta? Solo pochi illuminati. Non leggiamo i loro giornali, non conosciamo la loro storia presente e passata. Non indaghiamo i loro movimenti demografici, sociali, endogamici. Non sappiamo delle loro mutazioni sociologiche e antropologiche. La stampa ci racconta solo dei movimenti ai vertici di questi stati e non delle loro popolazioni. Per questo le loro rivolte ci hanno sorpreso come una doccia fredda. I nostri Stati sono amici dei loro governanti e non dei loro popoli. I nostri aiuti, spesso sinceri, sono giustamente mal accolti o rifiutati. La solidarietà è percepita come una fastidiosa ingerenza. Le Ong internazionali, che operano nei teatri di guerra o nelle zone colpite da catastrofi naturali, è difficile dirlo ma bisogna ammetterlo, hanno al loro interno infiltrati dei servizi segreti di mezzo occidente. Pilotare, caldeggiare rivolte, spiare l’attivismo di protesta di nazioni sofferenti e socialmente complesse, sotto le false spoglie della solidarietà, non aiuta questi popoli e non migliora la nostra immagine ai loro occhi. E a farne le spese sono proprio quelle organizzazioni che veramente operano in nome della solidarietà e dell’aiuto disinteressato. Basti ricordare l’abbaglio preso nei confronti di Emergency e da ultimo la tragica morte di Vittorio Arrigoni. Nell’anno europeo del volontariato occorrerebbe riflettere su questo spinoso aspetto nell’ambito delle politiche comunitarie. Questa nostra Europa, nata per unire e per accogliere, è sempre più inadeguata e lontana dal risolvere le controversie internazionali e le migrazioni di rifugiati e richiedenti asilo. Così come lo è l’Onu. Perché mai i popoli magrebini, mediorientali, euro-asiatici dovrebbero fidarsi della vecchia Europa, se chiudiamo loro le frontiere, dichiariamo false promesse, interveniamo in loro aiuto sempre e solo con la forza e mai con la diplomazia? Noi non rispettiamo le stesse regole che ci siamo dati e siamo incapaci di aiutare i nostri stessi stati comunitari in difficoltà. Shenghen e la Grecia ne sono l’emblema. Perché mai il resto del mondo dovrebbe emulare e fidarsi del nostro modello? Con molta ipocrisia difendiamo la nostra rappresentanza democratica, i nostri governi, espressione di minoranze che si comportano come maggioranze carismatiche e pseudo totalitarie. Ma questo stesso metro di giudizio non lo estendiamo agli altri. Se analizziamo la vicenda palestinese, l’occidente taccia di terrorismo il governo di Gaza. Ma ricordiamoci che il partito di Hamas è stato eletto da una larga maggioranza del paese per mezzo di regolari elezioni. Il coraggioso popolo palestinese ha scelto di sfidare i suoi leaders storici e l’intera comunità internazionale, con il rischio di non essere compreso e abbandonato, riponendo la fiducia nell’apparato di Hamas, per condannare la corruzione e lo stallo in cui si era impantanato lo storico partito di Fatah. I metodi poco ortodossi della lotta palestinese, sono una scelta di popolo e di governo. Così come lo è la forza e lo spargimento di sangue che adotta il governo israeliano, ma senza l’avallo dei propri cittadini. La ragion di stato non è più democratica delle ragioni di una nazione.
L’intero occidente, dunque, è chiamato anch’esso ad intraprendere una rivoluzione. Fare autocritica per essere credibili. Una rivoluzione culturale e di comunicazione. Credere in una nuova metodologia della pace: partendo da un luogo-comune, la pace come “co(no)scienza”, indagare e studiare la fenomenologia di guerra e di lotta in chiave antropologica. Osservare i fatti consapevoli della loro intrinseca diversità e peculiarità regionale. Stilare un nuovo linguaggio onnicomprensivo, ma non omologo, per tutta la casistica. Adoperare parole che esprimono conoscenza e non giudizi. Solo così, forse, saremo capaci di organizzare ed aprire percorsi di pace, che non lascino dietro di loro scie incendiarie mai risolte.

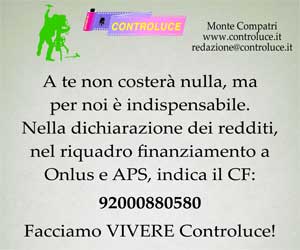



-ban.jpg)















































































































































































Non ci sono commenti, vuoi farlo tu?
Scrivi un commento