Lewis Hine e la fotografia sociale
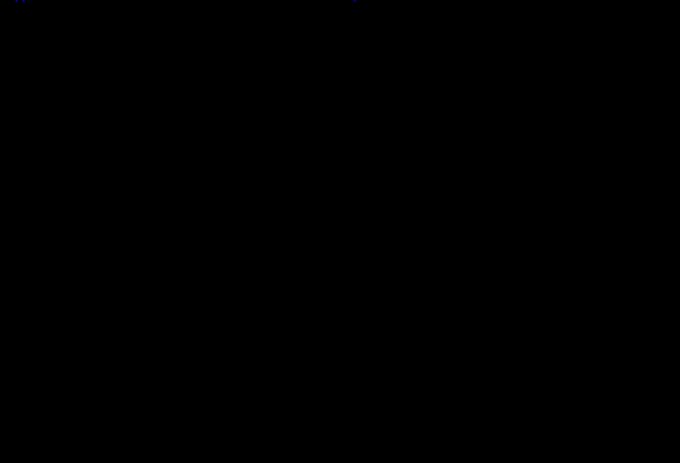
![]() È uno strano destino quello della Fotografia: usata per gli scopi più diversi, dalla foto segnaletica di un ladruncolo in un commissariato a quella astronomica per individuare nebulose e galassie e, stesso destino interscambiabile, i fotografi: un giorno inviati a una partita di pallone e il giorno dopo a fotografare l’inaugurazione di un cavalcavia. Sarà colpa delle caratteristiche del mezzo, così meccanico, così arrendevole? Oppure della superficialità degli stessi fotografi che quasi sempre hanno assecondato una certa ignavia della committenza?
È uno strano destino quello della Fotografia: usata per gli scopi più diversi, dalla foto segnaletica di un ladruncolo in un commissariato a quella astronomica per individuare nebulose e galassie e, stesso destino interscambiabile, i fotografi: un giorno inviati a una partita di pallone e il giorno dopo a fotografare l’inaugurazione di un cavalcavia. Sarà colpa delle caratteristiche del mezzo, così meccanico, così arrendevole? Oppure della superficialità degli stessi fotografi che quasi sempre hanno assecondato una certa ignavia della committenza?
Probabilmente tutt’e due le cose. Alla fotografia, e non solo, per certi versi anche alla pittura e al cinema e a tutto ciò che si può tradurre in immagini, si è sempre chiesto flessibilità, disponibilità, e in ultima analisi, versatilità (recentemente ho letto di un fotografo di successo, che attua una “copertura versatile degli avvenimenti italiani…”). Se andiamo a cercare i sinonimi di ‘versatile’ essi saranno, nell’ordine: duttile, elastico, adattabile. Quindi il lavoro del fotografo dovrà essere come un paio di guanti da cucina o qualsiasi altra cosa di plastica che vi venga in mente. E i risultati non tarderanno ad arrivare.
Lo sfasamento di senso, il deragliamento del significato e del segno, un uso del bianco e nero ‘di tendenza’ sono cercati e richiesti da ogni buon art-director che si rispetti, e i fotografi che si adeguano ai loro desideri, o hanno già un atteggiamento culturale incline in questo senso, vengono portati in palmo di mano. Immagini plasmabili, aperte ad ogni possibile interpretazione, buone per tutte le stagioni, ovviamente ambigue e inutili, soprattutto per chi le osserverà. Ma non è stato sempre così e, in altri tempi, anche non molto lontani, vi sono stati uomini che hanno prodotto immagini che non si facevano consumare nello spazio di un mattino, immagini difficilmente addomesticabili, splendenti di luce propria. Le fotografie di Lewis Hine sono così. Ancora oggi, guardandole, risultano implacabili, non danno scampo e per questo sono ancora più terribili. Come nelle icone ortodosse e bizantine del XIII secolo, dove i personaggi venivano ritratti frontalmente, affinché venisse stabilito un rapporto diretto con l’osservatore, anche le immagini di Hine sono prevalentemente frontali, ma a differenza di quelle, non narrano di santi e madonne, ma di martiri laici. Non si potrebbe chiamare diversamente quell’umanità afflitta che Hine va a cercare nei cotonifici della Pennsylvania, negli slums di New York, nei campi della Georgia o nella fortezza di Ellis Island, l’isola-prigione, l’isola delle lacrime, dove emigranti italiani, greci, russi, irlandesi o polacchi vengono rivoltati come calzini prima di poter effettivamente mettere piede sul suolo americano. Hine intitolerà una sua fotografia di una madre italiana con la sua bambina Madonna di Ellis Island, ma il riferimento all’arte medievale o Rinascimentale finisce qui. Hine non è un artista come Alfred Stieglitz, legato al pittorialismo e alle sue nuvole, che fotografa il Flatiron Building sotto la neve tanto da richiamare alla mente la Cattedrale di Rouen di Monet.
Hine è un sociologo, un insegnante della Ethical Culture School di New York e proprio grazie agli strumenti della sociologia approda alle immagini fotografiche, spinto dalla necessità di ribaltare i pregiudizi che la borghesia andava (ri)formulando sulle classi subalterne dell’epoca. Egli stesso da ragazzo aveva fatto i lavori più disparati per aiutare la famiglia e sicuramente aveva già visto bambini o adolescenti massacrarsi di fatica nelle fabbriche del Wisconsin dove era nato nel 1874. È pertanto una scelta di ‘classe’ quella che compie all’inizio del ‘900 e di conseguenza emerge la sua piena empatia nei confronti di chi si pone davanti al suo obiettivo. Andiamole a vedere queste immagini e osserveremo subito uno strano effetto: non siamo noi gli spettatori, ma i soggetti della foto che ci chiedono conto del loro destino, in una sorta di Spoon River alla rovescia. L’immagine di Mart Payne, ad esempio, raccoglitore di cotone di cinque anni in Oklahoma è senz’altro disperante, e usiamo un eufemismo, ma è un preciso atto d’accusa verso un’America dissennata e alla prova dei fatti ‘nelle mani di un dio irato’, un paese che, nascendo da una ‘violenza originaria’, non si fa scrupolo di votare intere generazioni a un destino di analfabetismo, di malattie, di estrema indigenza. Hanno nomi e cognomi questi bambini, ripresi nell’atto di raccogliere barbabietole o tabacco, colti in una vaga espressione, stupita, mai infastiditi. Edith, Chester, Bessie, Glenn: quello strano tipo, che per entrare nelle fabbriche o nei campi si faceva passare per venditore di Bibbie, annotava tutto, il nome, l’età, le scuole che avevano frequentato, la situazione familiare. L’affetto e la commozione sono visibili in ogni singolo scatto. In evidenza le mani, le braccia, le posture. E i volti, che oggi ipocritamente verrebbero ricoperti di ‘pixel’ per un travisato comune senso della privacy.





-ban.jpg)















































































































































































Non ci sono commenti, vuoi farlo tu?
Scrivi un commento