Le Favole di Ulsio Pasquino
Nell’antica Roma viveva un giovane di nome Ulsio Pasquino, ragazzo assai attivo e voglioso di imparare, conoscere e sapere.
Il nostro protagonista viveva in quel periodo di massimo splendore della città caput mundi. Si costruivano, grazie all’imperatore, strade, acquedotti, teatri e altre complesse edificazione in tutti i territori e le province, che andavano dalle isole britanniche all’Asia Minore.
Al centro dell’impero stava lei: la meravigliosa Roma.
Secondo il ceto e l’appartenenza si viveva presso la capitale in case più o meno ampie, ma la famiglia era sempre istituzione di fondamentale importanza. Ulsio Pasquino era fortunato e apparteneva a una famiglia assai ricca. La sua casa era una Domus, cioè la dimora dei patrizi, come erano chiamati gli aristocratici romani. Era una costruzione bella ma abbastanza elementare. Si entrava nell’atrio illuminato da una feritoia sul soffitto e subito si trovava una vasca, chiamata impluvio, che raccoglieva l’acqua piovana. Vicino era posto un tempietto per venerare i numi[1] familiari, e si pregava essi tenendo un braciere sempre acceso. Quella mattina Ulsio si era alzato presto. I genitori avevano partecipato a uno dei soliti festini notturni e si sarebbero destati assi più tardi. Il giovane era preso a invocare Giove, affinché il suo pedagogo greco Tigillio si sbrigasse a giungere.
“Anche oggi mi narrerà una fiaba educativa!” fremeva Ulsio Pasquino. Lui non era ancora coinvolto dai bagordi dei genitori e degli altri patrizi, aveva una considerazione assai alta di ogni essere umano, compresi gli schiavi e i liberti.
Sapeva che durante le ore notturne, alla festa alla quale erano andati babbo e mamma si era assistito a un incontro di lotta, fino al perire di uno dei due combattenti. Nella Roma Antica c’erano però anche coloro che si dedicavano alle lettere, rifacendosi all’immensa cultura greca. Uno di questi studiosi era proprio il suo Tigillio, insegnante tanto dotto e colto.
Finalmente Tigillio giunse. Era vestito sobriamente, data la sua semplicità d’animo. Non portava toga, ma solo una tunica chiara. In testa una corona d’alloro, in quanto premiato come filosofo.
“Perché ci hai messo tutto questo tempo?” domandò Ulsio Pasquino all’insegnante, allora il maestro gli narrò una fiaba sul tempo.
IL TEMPO
Tutta la città imperiale era preoccupata dallo scorrere del tempo. C’erano da preparare le feste di febbraio e marzo per Lupercalia e Quirino.
“Occorre ultimare il lavoro all’acquedotto!” si sgolava il console ai lavori pubblici.
I tribuni augustoclavi lottavano col tempo per preparare i cavalieri della legione, tutti pensavano all’avvicinarsi delle idi di marzo.
Ognuno s’impensieriva per lo scorrere incessante dei giorni e delle ore.
Alla zecca, coloro che creavano le monete, avevano paura di preparare troppo tardi le medaglie coniate con l’effige dell’imperatore.
Nessuno viveva più pensando alle cose importanti, come l’amicizia e la fratellanza.
Presso il foro si volevano allungare i turni di costruzione per terminare prima della fine del mese. I lavori pubblici erano tutti in ritardo e la cittadinanza romana era sconvolta.
Nella dilagante corruzione e tra i baccanali, nessuno pensava più alle cose vere della vita, ci si preoccupava solo del tempo. Ma un giorno i bambini scesero in piazza. Cominciarono a urlare il loro diritto di giocare. C’era chi teneva il compagno per mano e ballava, chi levatosi i sandali trotterellava divertendosi con repentine capriole e chi tirava in aria noci o noccioli di pesca. Alcuni si misero a giocare con carrozzini trainati da capre, altri fingevano di montare a cavallo cavalcando un manico di ramazza.
I bambini, coloro che venivano considerati come infermis, perché non pronti a comprendere la vita, avevano capito più degli altri che stavano perdendo il senso dell’essere. Fu così che si riappropriarono del tempo ritrovando le ore per giocare.
Meridiane e clessidre furono buttate via e riemersero principi di amore e fratellanza.
Dopo le feste di Minerva, cominciava l’anno scolastico e anche Ulsio Pasquino stava per tornare sui banchi. La sera avrebbe fatto i compiti col suo maestro greco Tigillio, ma la mattina doveva andare per sei ore a scuola, dall’alba a mezzogiorno, l’ora del prandium.
Proprio quel dì ricominciò la scuola. Lo schiavo personale svegliò Ulsio Pasquino, lo lavò, gli mise la tunica e lo accompagnò fino al forno per comprare la merenda che avrebbe consumato a metà mattina, poi gli disse:
“Buona scuola!” e Ulsio Pasquino si avviò alla semplice aula dove, insieme ai figli della plebe ascoltava la lezione, su una squallida seggiola e un grezzo banco; i suoi genitori infatti volevano che seguisse le lezioni insieme ai poveri, per imparare anche le cose della parte rozza di Roma.
Mentre Ulsio era a lezione, il maestro Tigillio camminava in casa tenendo in mano un libro di Platone. Lesse e camminò tutto il giorno, fin quando all’ora del prandium tornò il suo allievo. I due si fermarono davanti al fuoco sacro che ardeva sotto ai Lari e ai Penati[2] di casa. La Matrona Tusca, la mamma del fanciullo, era occupata ad alimentare la fiamma, come a lei spettava. Tigillio credeva in altri dei e aveva un’altra fede ma disse a Ulsio:
“La fede è una cosa fondamentale!”
La mamma aggiunse:
“Io devo far in modo che la fiamma non si spenga mai, affinché non s’innalzi l’ira delle divinità[i]!”
Il maestro cominciò dunque una fiaba sulle religioni:
LA FEDE
Per procedere nel lungo cammino della vita Lopio e Diuco dovevano lavarsi nel grande mare. Lopio era un essere devoto e pio, aveva una gran fede.
“M’immergerò e mi netterò da tutte le cattiverie!” disse umilmente rivolto a Giove.
“Io non credo nelle divinità!” ribatté Diuco, egli era un duro ateo e non aveva alcuna credenza, non anelava alla pace, non sognava la fratellanza.
Sulla riva le onde sciabordavano lente.
Entrambi si dirigevano nell’acqua.
Il cuore di Lopio era aperto e fiducioso. Egli credeva con tutto sé stesso in una divinità piena d’amore, per una tregua imperitura sulla Terra. Pensava al territorio dell’impero coronato d’amicizia, con i popoli conquistati accolti dai cittadini romani e un mondo di solidarietà e prosperità.
Diuco odiava il prossimo e non tollerava gli altri popoli.
L’acqua era ormai giunta alle loro spalle e i due continuavano a immergersi. Seguitarono e furono completamenti bagnati.
Avvenne il prodigio. Lopio era pulito da ogni male. L’acqua lo vivificò come una proteica pagnotta. Egli si sentiva forte e irrobustito. La fede lo aveva accompagnato. Due marosi schiumosi invece si scagliarono contro l’ateo ed esso stava per annegare, solo grazie all’intervento e alla fede di Lopio venne tratto in salvo. Da quel giorno anche Diuco imparò a credere. Il grande mare dove i due si erano immersi era il grande luogo delle religioni[ii], il pensiero sul Creatore, nel quale l’uomo trova la forza per andare avanti nella correttezza e nella giustizia.
In una parte della villa si apriva una grande porta e in essa si entrava nell’unctorium, ove il padre Scansius di Ulsio si faceva improfumare di oli balsamici dalle schiave. Decine di concubine agitavano ventagli, altre gli massaggiavano i piedi e le più belle e giovani lo ungevano. Da una parte ardeva incenso odor di sandalo. Ulsio era a scuola. Tigillio venne chiamato per leggere al padrone alcune pagine delle commedie di Tito Maccio Plauto.
“Che la gloria per te, oh nobile tribuno, sia sempre più alta!” disse il maestro greco entrando nella sala dell’unctorium.
“Salute a te oh mio pensatore!” rispose Scansius.
Le schiave avevano appena finito di ungerlo. Un’anziana donna portò la toga. Gliela fissò creando belle pieghe e fissandogliela sulla spalla sinistra. Scansius aveva gli occhi ancora assonnati, erano evidenti i segni di una notte brava, trascorsa a mangiare e bere davanti agli spettacoli dei festini.
Alcune schiave lavoravano vigorosamente poche once di pomice, biacca e schiuma di nitro, che sarebbe servita per massaggiare la pelle della padrona.
Nella sala attigua, infatti, si stava preparando alla giornata la mamma di Ulsio, Tusca, immersa in un bagno di essenze di gladiolo.
Tigillio dispose il suo rotolo di carte sul leggio, il padrone però aveva da lamentare le sue gesta:
“La mia politica e le mie parole hanno portato Roma a trovare la via giusta!” egli era infatti consigliere dell’imperatore “Nessuno però mi tributa onori né m’incensa!” protestava Scansius sfogandosi con il filosofo greco. Tigillio intanto pensava alla fiaba da raccontare al suo allievo Ulsio. Infatti la sera, quando giunse l’ora della narrazione, Tigillio raccontò al suo discepolo:
QUANDO FAI DEL BENE
Orum aveva combattuto da gran guerriero e aveva conquistato per il suo paese terre e possedimenti. Si vantava e ostentava i suoi atti. Andava avanti per la via suonando la tromba e annunciandosi.
“Inchinatevi e osannatemi!” diceva Orum.
Nessuno però lo acclamava né l’applaudiva.
Egli sognava le lodi dei cittadini, si vedeva cinto d’un serto trionfale, mentre gli altri in giubilo si felicitavano di lui.
Non c’era però verso di soddisfare i suoi sogni.
Orum si recò dagli aruspici, coloro che leggevano il futuro attraverso magie, sulle interiora degli animali sacrificati agli dei.
Gli fu risposto dai sacerdoti che avevano interpretato le viscere:
“Quando compi opere importanti non suonare la tromba innanzi a te!”
Orium provò a continuare a rischiare la vita per il suo popolo senza aspettarsi onori e tributi e divenne modesto. Fu allora che scoprì che la vera gioia del suo eroismo, non stava nel ricevere le lodi del popolo, ma nella soddisfazione di dare tutto sé stesso per il bene dell’impero.
Smettendo di suonare la tromba innanzi a sé, con la modestia, imparò a vivere.
L’idea degli aristocratici era che il popolo non dovesse imparare né acculturarsi. Le scuole pubbliche così, offrivano ben poco e la sera Ulsio doveva leggere Seneca, gli epicurei e gli stoici[3]. Era un gran darsi da fare, aiutato dal maestro greco. Le curiosità e le domande non mancavano. Ulsio scriveva sulle sue tavolette di cera i passi più belli di Seneca.
Intanto pensava all’imperatore e a tutti i senatori che temevano che il popolo s’acculturasse.
Mentre accadeva ciò e la plebe soffriva, i ricchi si davano alle feste.
Alle dissolute nottate, trascorse sdraiati sui triclini a bere vino e mangiare frutta, la mamma di Ulsio arrivava sempre con gran paludamenti. Il padre Scansius faceva a gara con gli altri patrizi per adornarla di gioielli e pietre e rare. Tusca era assai vanitosa e amava essere ammirata dagli altri.
Quella sera portava una novità, i crotalia, dei vistosi orecchini terminanti con delle perle.
“Come sei bella!” le disse quella sera Bicia “Però ho da farti un appunto: ma come fai a mandare Ulsio a scuola con il volgo?”
Nessuno comprendeva le decisioni della matrona Tusca e del tributo Scansius, che anelavano alla parità tra i ceti e al rispetto della dignità d’ognuno.
Tigillio era anche lui alla festa. Da buon greco si distingueva, non solo per l’abito semplice in quanto non nobile, ma anche per la cura di barba e capelli, assai ordinati. I romani solo da poco avevano cominciato a ad andare dal barbiere, proprio per imitare gli ellenici, farsi profumare, radere e tingere i primi peli bianchi. Tigillio appuntava e rifletteva assistendo a quei colloqui e il giorno dopo narrò dell’accaduto al suo allievo.
“Tua mamma è tanto cara, ella vuole che tu accetti e comunichi anche con i ragazzi poveri: devi sempre starle vicino: è una gran donna; ma tutte le mamme vanno trattate coi guanti d’argento!” quindi raccontò una fiaba a Ulsio.
IL LIBRO DELLA VITA
Nella grande biblioteca dei ‘libri della vita’ il fanciullo, di tanto in tanto si recava per leggere le pagine da lui redatte. Si narrava in essa delle scoperte, dei giochi educativi, delle varie esperienze.
“Diventerò un grand’uomo!” diceva il fanciullo immaginandosi adulto e onorato da tutti.
“Voglio imparare a far da solo, senza l’aiuto della mamma!” diceva sognando di andarsene da casa. Voleva imparare a vivere senza la vicinanza dei genitori, non comprendendo che a quell’età aveva invece di loro tanto bisogno. Il bibliotecario magico, allora, lo condusse a vedere il grande scaffale dove erano ben disposti i libri di tutti coloro che, suoi coetanei, stavano crescendo.
“Questi sono i libri di ogni fanciullo!” disse il bibliotecario.
Accanto a ogni piccolo libro c’era un tomo più grosso, al quale il minuscolo libercolo dei bambini si appoggiava.
“Come mai accanto a ogni rilegatura piccola c’è un grande volume?” chiese il fanciullo.
“Quello piccolo è il libro del bambino, quello grande invece è il testo della sua mamma, senza il quale egli non trova appoggio né sostegno!” fu la risposta e il fanciullo comprese quanto importante fosse sua madre.
Al centro della città imperiale c’era il Foro, luogo importante di mercato. I romani riempivano quel sito, sia per parlare ogni mattina, per spettegolare d’ogni cosa, che per celebrare eventi religiosi o avvenimenti. Al foro s’intrattenevano tutti i ceti. Si trattavano affari politici, sotto i portici bighellonavano i popolani, e vicino alle gallerie sostavano le matrone a chiacchierare. Era pieno di banchini, ricchi d’ogni merce: si vendevano ortaggi, bestiame, cereali, pesce e vino. Tante erano le strade che conducevano al foro e da ognuna continuava ad arrivare gente. Anche Tigillio ed Ulsio camminavano verso il foro. Il centro del foro era pieno di statue, altari e archi.
Le moglie dei notabili, come il babbo di Ulsio, godevano tutte di attenzioni e riguardi. La mamma di Ulsio era una delle donne più importanti.
“La famiglia è alla base di tutto!” mormorava Ulsio pensando a sua madre, ma il suo maestro voleva anche che il ragazzo imparasse a cercare la propria individualità e crescere.
“Sono tanto legato a mamma, non voglio camminare senza di lei!” si mise a fare le bizze il giovane, allora per fargli capire che bisogna trovare un giusto mezzo, l’insegnante condusse in un angolo l’allievo. I due si sedettero vicino al busto scolpito d’una matrona e il greco raccontò:
IL PULEDRINO
La Mandria galoppava allegra nel prato verde, il puledrino stentava in mezzo agli altri. Era un cavallino particolare, dal cuore dolce e tenero, ma non riusciva a trovare la forza per staccarsi dalle mammelle della giumenta e decidersi a crescere:
“Voglio ritornare nella pancia della mamma!” diceva il giovane redo.
Era un bel cavallo. Aveva il pelo già lucente, gli arti forti e cominciava a formarsi una possente muscolatura, ma egli voleva in ogni modo tornare dentro quella pancia.
“Mi sentirei al sicuro!” cominciò a piangere. I suoi coetanei giocavano a galoppare e sgroppare qua e là. Godevano dei raggi solatii, assaporavano l’erbetta tenerella, gustavano i profumi che si alzavano dal bosco sovrastante il pascolo.
Il puledro non volle però sentir ragioni e alla fine rientrò nella pancia della mamma. Ivi non c’erano pericoli.
Il puledrino si sentì al sicuro, ma subito si accorse che lì non c’era l’erbetta da mangiare, non c’erano olezzi, né la possibilità di giocare e galoppare, non si poteva crescere, imparare e scoprire… allora uscì nuovamente al mondo aperto e capì che ogni età ha bisogno di un luogo adatto e che si può essere vicini alla mamma anche percorrendo la propria strada.
Alzandosi all’alba per andare a scuola, leggendo, studiando e dedicando anche tempo al gioco, Ulsio Pasquino aveva sempre una gran fame all’ora del pasto principale, che consisteva nella cena. Il ricco patrizio infatti dedicava molta attenzione al cibo. Nella domus il pasto serale cominciava assai presto rispetto a noi, soprattutto nei numerosi momenti durante i quali si festeggiava qualcosa: la dea Veste, un trionfo in guerra, una conquista o un fidanzamento. Anche quel pomeriggio il banchetto era pronto. Dall’atrium, la parte centrale dell’abitazione, oltre che nella varie stanze si aveva accesso alla sala da pranzo. C’erano vari tavolinetti a tre gambe, fatti di bronzo. Ulsio e il suo maestro Tigillio erano accomodati in disparte, su un tavoletto isolato, per non disturbare i grandi che assistevano a recite di clown, letture di poesie, o ascoltavano cetre suonare. Era quello un pomeriggio in onore di Giove. Le posate erano d’argento e le ciotole d’ambra, nelle quali venivano servite zuppe d’asparagi, quaglie e olive. I commensali si sarebbero intrattenuti fino a tarda notte, anche se Ulsio poteva rimanere alzato solo un poco di più rispetto al normale. Guardava le danzatrici e intanto mangiava qualche fico. Che differenza rispetto ai poveri, che non avendo posto nelle loro misere insulae[4] dovevano mangiare nelle taverne[iii].
Tigillio passò la brocca di vetro con l’acqua fresca per il suo allievo. Ulsio nonostante l’aria di festa era pensieroso.
“Nelle mie vicende spesso mi accorgo di sbagliare, devo rinnegare le mie azioni e tornare indietro!” si sfogò con il saggio greco. Nelle pareti della stanza c’erano decorazioni tratte dalla cultura greca, il sapere ellenico, derivante da Socrate, Aristotele e Platone era ancora importantissimo. Il maestro greco, con dietro alle spalle una bella pittura, cominciò a raccontare:
UN PASSO INDIETRO
C’era una volta un fanciullo di nome Pic che camminava lungo il difficile sentiero della vita. L’esistenza del resto è un pellegrinaggio, un percorso che ci aiuta a crescere e a imparare.
Pic procedeva deciso. Aveva superato montagne, affrontato curve pericolose, attraversato pianure.
“Quanti paesaggi ho visto!” diceva.
Ai suoi occhi erano scorsi boschi, fiori, piante di mirto e lupinella. Aveva potuto osservare varie specie di animali: falchi, aquile, scoiattoli e daini.
Dopo tanto peregrinare Pic si trovò vicino alla collina dell’amore.
“Se salirai su quest’altura troverai la gioia del cuore!” gli disse una fatina gialla e rossa.
Era la fata della benevolenza, della fratellanza e dell’amicizia.
“Non vedo l’ora di salire!” disse Pic, ma per ascendere doveva fare un passo indietro. Pic non aveva voglia di rivedere il suo percorso, rinnegare gli ultimi metri e retrocedere di una falcata.
Eppure, se non si decideva a fare retromarcia, non sarebbe potuto arrivare al colle dell’amore.
La fata disegnò un cuore in cielo.
Pic guardava sempre deciso a non tornare sui suoi passi.
“Spesso si deve fare un passo indietro per poter poi fare un passo più lungo e andare per la giusta via!”
A quel punto il fanciullo comprese. Retrocesse, si piegò a ritornare sui suoi passi e così poté finalmente salire sulla collina agognata dove fu felicissimo e lieto.
Notevolissima conquista, per il popolo romano, fu la capacità di costruire splendidi acquedotti, per rifornire d’acqua le città, alimentare le terme, superare fiumi, oltrepassare problemi igienici. Furono i censori Appio Claudio Cieco e Caio Plauzio Venox a edificare la prima struttura ad archi e arcate, dando vita alla costruzione che prese il nome di Acqua Appia.[iv]
Nell’arco di una sola giornata arrivavano nella capitale oltre un milione di metri cubi d’acqua. Importanti erano le fontane, tanto che Roma diverrà per ciò, nota in tutte le epoche.
Ulsio e Tigillio si trovavano quella mattina presso la statua di un guerriero che sputava acqua dalla bocca. Era una gran fontana, essa per essere alimentata aveva dovuto superare il fiume, in una difficile opera.
“Ma come hanno fatto a superare il Tevere?” chiese Ulsio.
“Quando ci si mettono l’impegno e il cuore si supera ogni cosa!” rispose l’insegnante greco per poi iniziare una fiaba:
L’OSTACOLO
C’era una volta un cavallo bianco. Esso galoppava lieto attraverso campi d’erica. L’erba gli arrivava fino alle ginocchia e lui continuava a battere i begli zoccoli sul terreno, procedendo verso la strada del sole.
Un giorno però trovò un ostacolo immenso avanti a lui.
“Come farò ad andare oltre?” si chiedeva preoccupato il cavallino dopo essersi fermato.
Indugiava e non riusciva a trovare le forze per balzare oltre le barriere. Si trattava di un ostacolo altissimo, che avrebbe messo paura a chiunque e pareva impossibile riuscire a gettare il cuore al di là di esso, per conquistare il successivo tratto di strada verso il sole.
Il cavallino pensò intensamente alla sua mèta:
“Chissà quanto sarà bello conquistare la stella del cielo che tutto illumina e ogni cosa riscalda!”
Per darsi energie agognava a raggiungere l’astro del giorno, s’immaginava avvinto dai raggi pieni di tepore confortante.
Si sentì il muscolo cardiaco battere forte in petto. Il cuore pulsava. Lui si preparò al gesto atletico per saltare. La parabola cominciò con in mente la voglia altissima di andare oltre e conquistare il sole. L’impegno fu tanto che egli riuscì a superare il tremendo ostacolo, per andare così verso i raggi caldi del sole.
Al giovane Ulsio piaceva molto quando, nei giorni caldi, il suo maestro lo accompagnava al porto romano di Ostia. Lì i traffici commerciali erano intensi. L’impero romano, infatti giungeva sino in Britannia a nord, raggiungeva il continente africano a sud e a destra e a sinistra toccava Spagna e Mesopotamia: un’area vastissima. Presso i moli giungevano viaggi per mare recanti merci d’ogni tipo. Si vedevano carichi d’oro e argento, rame e stagno. Arrivavano animali sconosciuti dal continente nero, porpora e ambra da posti esotici, grano, frutta e persino schiavi imbarcati in squallide trireme. Da un’ immensa barca Ulsio assisteva allo scarico di pelli, lana e pellicce che sarebbero servite per commerciare abiti e vesti. I viaggi via terra erano troppo lenti e veniva preferito l’accesso attraverso il porto ostiense. Il Tevere terminava qui, per gettarsi nel Tirreno. A Ostia lavoravano e abitavano almeno cinquantamila persone, tra armatori, commercianti, artigiani, funzionari e marinai…[v]
Erano proprio coloro che facevano parte degli equipaggi che colpivano la fantasia di Ulsio. I comandanti delle navi arrivavano con monete recanti l’effige dell’imperatore. Il fanciullo considerava questi uomini degli eroi:
“Che gesta favolose, che carisma, che tempra!” diceva sognando un giorno lui di comandare una trireme.
Mentre dei carri trainati da buoi, venivano caricati con le merci sbarcate, i capitani davano ordini. Ostia godette del favore imperiale sino all’età dei severi e passerà alla storia il suo ruolo.
Il maestro greco volle spiegare al suo allievo, che non c’era poi occorrenza di eccezionali imprese, come quelle dei capitani, per sentirsi degli eroi e quindi narrò una favola:
L’EROE
L’uomo dei fiori viveva coltivando con amore viole mammole e gardenie, tulipani e rose. Il gran giardino profumato era variopinto di petali e olezzava soavemente. Farfalle e api raccoglievano il nettare e coloravano l’aere, mentre gli uccellini cinguettavano allegri sui rami dei peschi in fiore.
Il protagonista di questa storia amava con tutto il cuore il proprio lavoro, ma non si sentiva soddisfatto delle sue gesta. Studiava con accuratezza ogni tecnica di coltivazione, sfacchinava con rastrello e vanga tutto il giorno, annaffiava le piante, accarezzava le corolle ma diceva:
“Vorrei essere un eroe!” e si compiangeva ammirando le imprese ardite di condottieri e guerrieri.
Un giorno il sole era particolarmente bello in cielo. L’uomo dei fiori incedeva lento per il viale costeggiato da ontani e oleandri. Vi erano petali rossi, rosa e bianchi, in un fantastico gioco di tinte. Accanto ai fiori sorgeva un bel salice. L’uomo dei fiori cerco un pò di fresco ai piedi del salice, che era un albero magico e parlante. Il giardiniere borbottò tra sé e sé:
“Come vorrei essere un eroe!”
Il bel salice prese a proferire:
“Ognuno è un eroe. La vita è un’avventura. Anche curare un viale d’alberi e dedicarsi ai fiori è un’opera degna di plauso: sei il nostro eroe!” disse l’albero.
L’uomo dei fiori si commosse e due lacrime di felicità scesero sulle sue guance. Le stille di pianto caddero a terra e divennero due splendide monete d’oro.
Quella sera il maestro Tigillio portò Ulsio Pasquino a teatro. Fu una bella esperienza. Gli attori erano per lo più greci e rappresentavano storie di schiavi acuti, aneddoti, mimi. Le vicende s’ispiravano alla mitologia antica. Le gradinate erano disposte a semicerchio e le scene innalzate in numerosi piani. Si alzò il velario e la recita ebbe inizio. Ulsio guardava interessato, mentre gli attori erano accompagnati da canti e musica[vi]. Tipico personaggio delle commedie romane era lo schiavo pettegolo e furbo e quella sera Ulsio rise di gusto assistendo alle sue pantomime.
“Sono felice!” diceva il giovane romano mentre il suo maestro lo riaccompagnava alla domus paterna.
“Mi sento bene, riuscirei ad amare tutto il mondo!” affermò Ulsio, ma proprio sui suoi passi incrociò un bisognoso e lo sprezzò con crude parole.
“E’ facile dire di amare il mondo…!” commentò Tigilllio, ergo narrò al suo discepolo:
AMARE L’UMANITA’
Nevo andava fiero delle sue belle parole:
“Amo l’umanità!” diceva e ciò era bello, non fosse stato che queste erano affermazioni che volavano nel vento.
“Viva la fratellanza, l’unione del globo, il mondo in pace!”
Tutti vocaboli da scrivere per sempre sulla pietra, ma non accompagnati da adeguate azioni.
Nevo, infatti odiava chi gli passava accanto, non sopportava il vicino, aborriva ogni persona che gli si presentava innanzi.
Un vento freddo si alzò nel cielo, l’aria impetuosa scuoteva i rami degli alberi e le foglie cadevano per la via. Nevo era impaurito, pareva che quel vento ce l’avesse proprio con lui. Si mise a correre e scappare. Fuggì lontano ma il vento lo seguiva. Eolo sbuffava arrabbiato, mentre il misantropo si alzava il bavero per proteggersi il volto dalle folate. Quasi non riusciva più a respirare, tanta era la forza delle ventate, quando Nevo urlò:
“Perdono!”
Dal cielo s’innalzò il volto di Eolo che sentenziò:
“E’ facile amare l’umanità, il difficile è amare quello della porta accanto[vii]!”
Nevo s’inginocchiò e da quel giorno non sprezzò mai più il vicino, abbracciò i compagni, sorridendo ad ogni incontro ed Eolo si trasformò in un dolce zefiro che lo accarezzava, gli dava frescura nelle giornate calde e tepore, con vento di scirocco, nei dì freddi.
Assai apprezzate dai romani erano le terme, alle quali si recavano il pomeriggio, dopo una mattinata di lavoro. Il maestro Tigillio, accompagnò Ulsio alle terme. Nell’apodypterium (lo spogliatoio), il bimbo si levò l’infantile tunica e subito si coprì con un asciugamano, il pudore era infatti assai importante tra i romani. Le case dei patrizi avevano un bagno privato, ma a tutti piaceva recarsi alle terme, frequentare compari e divertirsi. Tigillio pose gli indumenti dell’allievo sugli appositi scaffali, mentre il giovane faceva un po’ di ginnastica preparatoria al bagno. Nelle camere calde i due iniziarono una specie di sauna, quindi s’immersero nella piscina fredda dove si lavarono con l’olio d’oliva, che a quei tempi sostituiva il sapone. Dopo essersi dilatati i pori della pelle, adesso venivano richiusi con la bassa temperatura. A conclusione del bagno ci furono i massaggi rilassanti e durante questi Ulsio cominciò a fare domande sui genitori:
“Ma perché ci si sposa? Perché si divide la propria vita con una compagna?” chiedeva a Tigillio, il quale rispose con una storiella:
NON MI VOGLO SPOSARE
Il legionario era tornato dalla guerra, promesso sposo alla bella lavandaia, egli aveva paura del matrimonio.
Già era stato preparato il panis farreus, focaccia cucinata con il farro, che sarebbe stata data agli sposi per celebrare la loro unione[viii]. Il legionario protestava:
“Non voglio dividere la mia vita con nessuno!” diceva rivolto al tempio di Venere, chiedendo alla dea di poter rimanere scapolo.
La sera antecedente la celebrazione, la bella lavandaia si era preparata con cura. Le sue schiave le avevano legato i capelli in una reticella color carminio e si presentò come una statua, con l’abito nuziale composto da una tunica serrata alla vita, con una stupenda cintura di lana. Incedeva verso l’altare, mentre il legionario pensava ancora a Venere.
“Non voglio sposarmi e perdere me stesso!”
Un sacerdote pose una corona di mirto e fiori d’arancio sulla testa della sposa. I presenti gridavano: “Feliciter!” alla coppia, ma il legionario sperava ancora, fino a quando gli apparve nella mente Venere stessa, che stupenda gli disse:
“Dividerai il pane, le ore, i dolori e le gioie: per magia d’amore le pene dimezzeranno e la felicità sarà doppia!” e finalmente il legionario capì che sposarsi non significava perdere la propria identità.
Almeno un giorno sì e uno no, si celebravano a Roma, a spese dell’imperatore, festività e cerimonie. Ciò era occasione per assistere a spettacoli eccezionali al Circo Massimo, dove le più amate erano le corse di cavalli. Ulsio e Tigillio allora, scendevano dall’Aventino in direzione della pista di gara, per assistere alle numerose corse che in una sola giornata potevano essere anche più di venti. Splendidi destrieri trainavano una biga, ovvero un cocchio tirato da una pariglia. Le bighe erano stupendamente colorate e i tifosi osannavano i loro beniamini.
“Forza!”
“Dai!” inneggiavano dagli spalti indicando l’una o l’altra auriga. L’auriga era il cocchiere, che con la frusta in mano guidava la coppia di cavalli, appoggiando una mano sul cocchio, anteriormente di forma semicircolare.
Era difficilissimo manovrare i carri, assai leggeri.
A volte nel palco centrale sedeva l’imperatore in persona, con sulle spalle un mantello color ametista, la tunica candida e la corona d’alloro e tutti applaudivano Cesare.
Una processione di suonatori dette il via all’evento. Ulsio osservava ammirato l’avvicinarsi dei cocchi, che stupendamente decorati apparivano bellissimi. I cavalli vivevano in scuderie speciali ed erano attentamente allenati. Più di duecentocinquantamila persone erano presenti. Per ultima si sarebbe vista la corsa delle quadrighe, con quattro stupendi equini a tirarle.
Fu una giornata molto bella, ma Ulsio raccontava bugie in quantità. Diceva di essere lui stesso un guidatore di cocchio e durante i sette giri nei quali consistevano le emozionanti gare, andava inventandosi frottole a destra e a sinistra.
Durante il ritorno a casa, anziché ammonirlo per le bugie, il suo maestro decise di narragli una favola:
IL SACCO DELLA VERITA’
Dalle alture nebbiose scese un giorno di settembre un vento tiepido che portava con sé parole per i cercatori d’oro.
“Potrete trovare il tesoro se sarete sinceri e puri!” diceva lo zefiro.
I cercatori si prepararono gioiosi e vogliosi al viaggio, tutti con la speranza di trovare un bel forziere di gioielli e monete preziose.
“Cosa metterai sul tuo carro?” chiese Jhon a Kim.
“Metterò tanta furbizia!”
Kim andò verso l’orizzonte, ma con il sacco di furbizia fece ben poco e tornò mesto, a mani vuote.
“Cosa porterai?” chiese Jhon a Leon.
“Un sacco di sagacia!” ma anche Leon tornò con la coda tra le gambe.
Il vento tiepido tornò a parlare.
“Sarà proprio il contenuto del sacco che vi permetterà di trovare il tesoro!”
Si provò a mettere nel sacco ogni cosa, dai fiori alle armi, dal ferro al legno, tuttavia il tesoro non veniva mai trovato.
Jhon però aveva capito le parole del vento che aveva detto siate sinceri e puri.
“Porterò un sacco pieno di verità!” disse Jhon decidendosi a partire. Con il sacco colmo di verità giunse fino alla Grotta Alta. Un’enorme porta si aprì magicamente. Egli entrò e trovò un ricchissimo tesoro: la verità porta sempre lontano.
Le affollate vie di Roma erano costeggiate da tantissime botteghe, dove lavoravano indefessi molti artigiani. C’erano i falegnami e i carpentieri che davano vita a botti, ruote, carri. Modellavano il legno sui bordi della via, dove si apriva il loro negozio. Bellissimi erano i mobili, specie quelli lussuosi di legno d’acero. I poveri avevano case assai spoglie, pertanto i clienti dei falegnami erano solo i patrizi, ma la plebe frequentava i bottegai per parlare e scambiarsi notizie, così c’era sempre una gran folla. Anche la pietra era un materiale che i romani sapevano lavorare bene e non mancavano le botteghe presso le quali si modellavano, con maestria, lapidi o simili per mezzo di scalpelli e picconi[ix]. Altri oggetti che venivano esibiti nelle botteghe erano vasi, vetro colorato, metallo lavorato, fino ad arrivare, nelle vie importanti, alla gioielleria. Per le matrone importanti, erano presenti anelli preziosi e pendagli d’argento. Ulsio venne attirato invece da una bottega meno ricca: quella del fabbro. Con delle pinze d’acciaio esso stava forgiando un ferro che il maniscalco avrebbe poi messo agli zoccoli del cavallo e proprio riguardo all’amore che si deve avere per i destrieri, Tigillio narrò una favola che il giovane romano ascoltò con attenzione:
IL CAVALLO TIGNOSO
C’era una volta un guerriero senza cavallo. Egli amava tanto gli equini e sognava un giorno di poter avere anche lui una cavalcatura per poter essere al pari dei suoi compagni.
Tanto fu l’ardore con il quale desiderò di poter salire in sella, che un giorno, nel bosco, la dea Diana gli fece trovare un piccolo sauro. Esso era però un cavallo tignoso e malato.
“Come farò a far ingrassare questo magro cavallo, tanto gracile e malandato?” si chiedeva il guerriero. Diana rispose:
“Ti serviranno rispetto, impegno, amore e buona volontà, vedrai che otterrai dei risultati!”
Tutti gli altri guerrieri prendevano in giro l’aspirante cavaliere:
“Hai tra le mani un ronzino!”
“Perdi il tuo tempo!”
Egli però aveva ben compreso le parole di Diana ed era deciso a dare tutto sé stesso per onorare il suo destriero.
Cominciò a curarlo con il cuore. Lo allevò e lo fece vivere con abbondante acqua, fieno, biada e frutta.
Presto il cavallo divenne muscoloso e forte, bello e veloce. Il cavallo lo portò per un’erta strada in mezzo alla pineta. Dagli alberi colava una resina profumata, il cavaliere si lasciò guidare dal suo corsiero. Giunsero presso un tronco cavo dove il guerriero trovò un immenso tesoro. Era proprio valsa la pena dedicare tutto quell’amore al cavallo. …E gli altri guerrieri rimasero attoniti guardando e con ammirazione.
L’estate romana era giunta ormai alla conclusione, ma ogni stagione era adatta, per il popolo, alla celebrazione di eventi e feste. Importanti, anche se meno che in Grecia, erano gli dei della musica. Si celebrava il dio Pan con la sua fistola, tradizionale strumento dei pastori. S’ inneggiava a flauti e pifferi magici, si usavano il corno a spirale, cetre e lire. A teatro naccheraie coperte da pochi veli, danzavano mentre i musici creavano sonore atmosfere. Erano spettacoli tenuti con l’intento di addolcire, per mezzo della musica, le ire degli spiriti maligni e calmare gli dei, come era avvenuto durante la pestilenza del IV secolo avanti Cristo. I concerti avevano così funzione seria e importante. Ulsio amava tanto assistere alle esecuzioni musicali a teatro. Soprattutto ammirava l’impegno col quale i musicisti imparavano a suonare.
Essi erano infatti educati al dovere e all’alacrità in speciali scuole musicali.
“Bisogna sempre trovare la forza per crescere e tentare continuamente di migliorarsi, non è bene esser iperprotettivi nei confronti di chi cresce e si addestra!” disse Tigillio al suo allievo e gli narrò una favoletta:
IL SALTATORE
Tutta la Grecia era coinvolta negli emozionanti giochi olimpici. Gli atleti provenivano dall’Arcadia, dalla Laconia, dall’Acaia e da Messenia. Il pubblico era in attesa; tutti assai eccitati presso lo stadio si agitavano e tifavano. Poeti e letterati scrivevano degli agoni, re e principi assistevano insieme a tutto il popolo, all’emozionante spettacolo.
Arc era un saltatore che voleva competere con gli altri. Si allenava ma la sua mamma, per tentare di aiutarlo, ogni volta che lui voleva compiere un balzo al di là delle barriere interveniva. La genitrice spostava l’ostacolo avanti, credendo così di porgergli soccorso.
“Non riesco proprio a saltare!” si lamentava Arc, ma ogni volta la madre continuava a portare lontano l’ostacolo.
L’atleta guardava i partecipanti all’agone compiere plastici gesti. I vincitori venivano onorati, mentre un lettore declamava versi.
La mamma di Arc continuava a soccorrere il figlio spostando i suoi ostacoli[x].
Un giorno finalmente la mamma si dimenticò di portare oltre gli ostacoli, Arc poté saltare e fu il trionfatore, cinto d’alloro e con al collo la medaglia, in un tripudio di festa e acclamazioni.
Principalmente la vita si svolgeva nella città Caput Mundi, ma anche le campagne erano attive. Gli schiavi lavoravano alacremente la terra, custodivano greggi, coltivavano ulivi e si occupavano di vigneti. Proprietari delle grandi tenute erano i ricchi e anche Scansius, il padre di Ulsio, da buon patrizio aveva i suoi appezzamenti. Nelle giornate più calde, Ulsio si faceva portare in campagna, nei terreni del babbo, a frescheggiare. Erano gli ultimi dì soleggiati di settembre e Tigillio accompagnò l’allievo a vedere le falci all’opera. I cereali coltivati erano tanti. C’erano campi già mietuti, altri maturi, altri già pronti per la nuova semina. Il cereale preferito era il frumento, il clima dell’intera Italia era propizio e la penisola, con le nuove tecniche agricole, era considerata un immenso frutteto. Piano piano gli aratri, che erano fatti in legno, furono fabbricati in bronzo e i lavori campestri divennero sempre più attivi.
In quel settembre si preparava la vendemmia.
“Avrei paura a usare le cesoie o la falce: io non sono bravo a maneggiare arnesi!” disse Ulsio, da gran fifone.
“E’ perché non hai fiducia in te stesso! Si deve far attenzione nel gestire lame e coltelli, ma se si ha autostima si riesce a fare tutto!” ribatté il maestro e narrò:
IL GATTINO FIFONE
C’era una volta un micino che non riusciva a tirar fuori le unghie, i topi lo beffeggiavano, gli amici lo lasciavano da una parte, non riusciva a comportarsi da vero felino perché non aveva fiducia in sé stesso.
“Non sono buono a niente!” diceva il gattino e non riusciva a fare nulla.
Ogni dì che trascorreva, il micio aveva sempre più paura e non riusciva a crescere né a imparare niente.
I suoi coetanei sapevano saltare da un albero all’altro o giù dai tetti, erano capaci di imprese ardite e non mancavano di fortezza.
“Io ho paura!” continuava a dire il gattino, arruffava il pelo, arcuava la schiena e rigido come un palo si nascondeva nel buco.
“Il coraggio copre l’eroe meglio che lo scudo il codardo[xi]!”
Sentì dire da una nuvola. Allora si decise. Pensò dentro di sé di essere una tigre e da quel giorno, con tanta autostima, non ebbe più paura di niente, per poter crescere imparando e conoscendo tante cose.
La medicina, ai tempi dell’impero romano, era ancora assai legata alla magia, alla stregoneria e alle maledizioni. Si credeva che le epidemie fossero scatenate dagli dei. I dottori erano per lo più greci e assai costosi, cosicché solo i patrizi potevano farsi visitare. Molti metodi curativi si perdevano nei riti e si poteva morire anche per una semplice febbre, c’erano però alcune pratiche legate alle antichissime arti, che erano efficaci, quando si faceva ricorso a erbe officinali. Si conoscevano ad esempio le proprietà digestive del finocchio, si impiegavano unguenti a base di essenze fiorifere spalmati con apposite spatole, che il medico adoperava secondo gl’insegnamenti di Esculapio. Sull’isola Tiberina era proprio stato costruito, in onore dell’antico studioso greco, un tempio, per ringraziarlo della scampata epidemia di peste del III secolo a.C.. Vicino all’isola svolgevano il loro lavoro molti medici. Quella mattina Tigillio portò a farsi visitare il suo allievo. Si trattava di un controllo ma il medico sentenziò:
“Ci vuole più esercizio fisico!” i romani infatti, tenevano assai agli esercizi ginnici. “Potresti fare della danza!”
Il giovane Ulsio pensava alla danza come a qualcosa di effeminato. Il suo maestro allora, per indurlo a darsi alle arti ballerine gli raccontò una storiella:
PER SCONFIGGERE L’IDRA
Nel fiume che offriva alla città l’acqua necessaria, apparve un’idra a sette teste. Fu tremendo, non si poteva più attingere da bere, né ci si poteva lavare.
Provarono in molti a uccidere l’idra. Con spade, scimitarre e pugnali, molti guerrieri perirono sulle rive del fiume sotto le spire dell’idra che si scatenava su ogni combattente.
“Ci vuole qualcosa di magico!” si mise a dire il popolo.
Arrivò Leon, grande danzatore. Cominciò a compiere passi coordinati e armonici. Il suo corpo comunicava, era puro linguaggio, esprimeva armonia e ritmo. I pifferi e i flauti dei musici si misero ad accompagnare la sua danza. Erano gentili i suoi movimenti, ma al contempo maschili e forti. Una luce illuminò le sue membra che volteggiavano al cospetto dell’idra, erano sequenze di gesta dense di significato e si vedevano i suoi muscoli tendersi poderosamente. Il suo corpo si mostrava robusto, dopo anni e anni di esercizio. Si videro gli spettatori a bocca aperta, spiare nascosti dietro al canneto per paura del mostro. Il ballerino danzò per sette giorni. Alla vista di quel corpo tanto potente a ogni dì cadde una testa dell’idra, fino all’ultimo giorno quando era rimasta una sola testa. Fu messo uno specchio dietro al danzatore. La sua immagine divenne doppia e anche l’ultima testa cadde innanzi a quell’epica danza: l’idra era sconfitta per sempre.
Molti erano gli dei ai quali gli antichi romani erano devoti: c’era il tempio per Minerva, quello dedicato a Giove, a Giunone, Saturno e Nettuno. Il pontefice massimo era l’imperatore stesso, aiutato dalle vestali, ovvero le sacerdotesse sacre. Mano a mano però, la fede veniva sempre meno e i culti divenivano solo una maniera per fare feste e bagordi. Intanto nasceva il cristianesimo, inviso allo stato.
Ulsio assisteva alle varie celebrazioni: ora una festa in onore di Quirino, ora un rito per Venere. Da una coppa si versava un liquido profumato e s’innalzava un fumo in onore degli dei. Mancava tuttavia la capacità di credere veramente, c’era solo la voglia di bere e mangiare. Era però il Cesare che si preoccupava solo di offrire Pane e Circensis, per avere il popolo sottomano.
“Dipende da come agiamo se poi possiamo raccogliere frutti!” disse il maestro greco allo scolaro riguardo alla vera fede, e gli raccontò:
IL GIORNO DELLA MIETITURA
Un giorno venne il tempo della mietitura. Le messi biondeggiavano nei campi dei lavoratori. Sarebbe stato un raccolto ricco e i granai sarebbero stati pieni.
“Festeggiamo!” erano trionfanti i contadini.
Si decise di celebrare con un gran ballo sotto la luna.
Si apparecchiarono banchetti e si fece gran baldoria. Le donzelle danzavano e i ragazzi suonavano flauti e armoniche.
Dall’altra parte del contado c’erano coloro che non avevano lavorato. Essi erano i fannulloni e ora piangevano:
“Noi non abbiamo niente da raccogliere!” si lamentavano. Invidiavano i granai colmi degli altri, avrebbero voluto anche loro avere motivo di far festa, ma invece dovevano solo rammaricarsi per la mancanza di frutti.
Le loro messi non erano cresciute. Essi non avevano arato né coltivato.
“Poveri noi!” si davano pena. Un anziano colono, chino vicino al campo, in atto di ricominciare subito a lavorare, procedeva a una nuova semina.
“Perché sei già al lavoro?” chiesero i coloni fannulloni all’anziano ed egli rispose:
“Nel giorno della mietitura potrà raccogliere solo chi ha ben seminato!” e tutti compresero che si doveva cominciare a lavorare con lena. Anche i fannulloni presero vanghe e zappe e l’anno che venne fu ricco di raccolto anche per loro, che così diedero vita a una gran festa sotto alle stelle.
L’organizzazione sociale, nella Roma antica era assai rigida. Innanzitutto si distingueva tra cittadini, abitanti delle province e schiavi. I cittadini a loro volta si dividevano in patrizi, cavalieri e plebe. Ulsio Pasquino e la sua famiglia appartenevano alla classe privilegiata, indossavano una toga le cui pieghe erano preparate con cura dalle schiave, portavano importanti anelli e viaggiavano scortati dai servi su imponenti lettighe. Il cittadino aveva pieni diritti, poteva partecipare con possibilità di voto alle assemblee ed essere residenti in Roma conferiva gran vanto.
Tuttavia, più che al ruolo di senatore o magister, Ulsio Pasquino aspirava da grande a divenire cavaliere, o equitas. Sognava di possedere un bel cavallo da battaglia.
“E’ bello da bambini anelare a un grande futuro. Sogna pure Ulsio, usa la fantasia!” diceva il maestro a Ulsio e per insegnargli a usare la capacità di immaginare, raccontava spesso lui favole come quella che segue:
IL QUADRO FANTASTICO
C’era una volta un popolo oppresso dal tiranno. Il despota angariava ogni cittadino, pretendeva gabelle e faceva pagare tasse, frustava la gente e metteva alla berlina chi era buono e pio.
“Non ne possiamo più!” dicevano tutti.
Il saggio del paese cercava di dare vigore ai compaesani:
“Abbiate fiducia, pensate a un buon futuro!” ripeteva sempre.
Uomini donne e bambini lo ascoltarono e impararono a credere nella provvidenza, sperando in un futuro roseo. Avevano appreso come cogliere l’essenza della vita, bastava loro vedere un fiore sbocciare per sognare fate ed esseri buoni.
La loro capacità di aspettare fiduciosamente era tanta e tale, che un giorno avvenne un fatto straordinario. Nel portico presso il foro era dipinta una scena di guerrieri che difendevano dall’oppressore. Il popolo si mise innanzi al quadro e fantasticò con tutto il cuore.
“Guardate: i cavalieri si muovono!” iniziò a urlare il saggio.
I cavalieri, grazie alla fantasia, uscirono dal quadro e presero vita. L’immaginazione può tutto. Guerrieri a cavallo si diressero al palazzo del tiranno e lo scacciarono per sempre, più il popolo sperava e più un maggior numero di guerrieri usciva dal quadro e li difendeva. Furono finalmente liberi e compresero quant’è bello immaginare e fantasticare.
Da pochi anni, cominciato dall’imperatore Vespasiano e ultimato dal figlio Tito, era stato edificato, colà ove un tempo sorgeva la Domus Aurea di Nerone, l’Anfiteatro Flavio, meglio noto con il nome di Colosseo. In esso si proponevano alla gente spettacoli di ogni tipo, molti dei quali assai sanguinosi, con l’offerta agli dei di chi periva nei combattimenti. Vogliosa di sangue, la popolazione assisteva entusiasta a belve che sbranavano schiavi, o a gladiatori che si uccidevano, ma sono note all’interno del Colosseo anche le naumachie, ovvero le battaglie navali. La grande platea, a forma ellittica, venne progettata con attorno gradinate in marmo, divise in settori, per diverse categorie di pubblico, dai senatori con panche di legno ai posti inferiori; naturalmente il più importante era il palco imperiale. Perivano animali e gladiatori, si massacrarono cristiani e innocenti. Costruito in mattoni e rivestito di travertino, il Colosseo è ancora oggi imponente e considerato una delle attuali 7 meraviglie del mondo. Delle torce illuminavano i sotterranei dai quali salivano nell’arena gli sventurati protagonisti di quei giochi sadici, ai quali assistevano anche 50mila persone urlando e agitandosi. Era l’imperatore in persona che pagava il tutto, per guadagnarsi il favore del popolo.
“Quanta violenza!” commentava in riferimento agli spettacoli il piccolo Ulsio.
“Eh già!” rispondeva Tigillio nella sua veste bianca da maestro e con il libro in mano. “In questo argomento devo dar ragione a Seneca che odia tale sprezzo della vita!” continuava l’insegnante.
“Ma la cattiveria e la malvagità sono tanto importanti?” chiese il giovane romano.
“No! La bontà è certo più forte, ti narrerò una favola in proposito!” e il greco iniziò a narrare:
IL CAPRAIO BUONO
Un anziano capraio aveva nella vita affrontato dolori e fatiche, ma aveva capito tanto del senso dell’esistenza; così la mattina all’alba prendeva il suo armento e con la pace nel cuore si avviava a gustare il profumo dell’erba fresca e a godere dei primi raggi dell’astro del giorno. Purtroppo i cattivi giravano per le campagne, piene di briganti e ladroni che facevano scempio d’ogni cosa e recavano il terrore attorno al paese.
“Come vorrei portare la tregua!” pensava in cuor suo il capraio.
Quel dì incontrò sul suo percorso una vecchia affamata, egli si fermò, munse una capra e le offrì del latte al quale accompagnò una focaccia dolce:
“Tieni oh donna, gustala e rifocillati!” disse il capraio generosamente.
Quella vecchia era una fata travestita.
“Ti premierò donandoti un mantello per recarti in ogni dove!” disse l’essere magico. Fu così che la bontà del capraio venne ripagata da quell’oggetto fatato. L’anziano uomo se lo mise sulle spalle, sempre anelando a rendere il suo paese un luogo di tregua e di felicità.
“Dove andrò con questo mantello?” meditava e pensò a lungo.
Alla fine prese una generosa decisione, non volle andare a scoprire tesori o gran ricchezze.
“Andrò nel cuore dei cattivi!”
Il mantello lo portò nell’animo dei malvagi e dei malfattori dove egli parlò di amicizia e fratellanza, i briganti si pentirono e la pace regnò per sempre nella sua città.
Ulsio era nel giardino della domus paterna, c’erano vasche, splendide, statue che raffiguravano Giunone e Venere, una grande fontana prima del porticato. Sotto i loggiati figuravano bei mosaici a tinte allegre. Incatenato davanti all’arco d’accesso, stava un feroce cane da guardia. Nella sua bella casa, Ulsio era però triste, pensava ai momenti nei quali la fortuna gli volgeva le spalle.
“Bisogna sempre essere ottimisti, dopo i momenti tristi vengono quelli belli!” cercava di dar lui morale Tigillio e gli raccontò:
LA FORTUNA E’ UNA LADRA SPECIALE
Mon era un ricco emiro dell’oriente. Aveva un palazzo coi vetri di cristallo e le maniglie delle porte erano di platino. Ogni vano aveva sulle pareti drappi d’argento e d’oro e ricamate sui vestiti aveva le proprie cifre decorate da zaffiri.
Viveva però con il terrore che la buona sorte se ne andasse.
“Cosa farei se arrivasse la malasorte e mi portasse povertà e sfortuna?” diceva.
Si guardava intorno per osservare se notava la dea Bendata giungere e cambiare la sua vita. Aveva una fifa tremenda, non dormiva più dall’apprensione. Gli schiavi agitavano ventagli per rinfrescarlo, i musici di palazzo suonavano nenie concilianti il sonno, ma lui ormai non riusciva a riposare da mesi e mesi.
“Ho tanta paura che giunga la cattiva sorte e muti la mia esistenza!”
Una notte, come al solito da Mon trascorsa insonne, una figura scura si mosse dietro alla tenda di velluto dell’ampia finestra che dava sul cortile. Mon si avvicinò alla veranda. Vide la dea della fortuna: essa era una ladra. Felpata, la ladra prese una grande moneta d’argento e la portò via.
Mon cominciò a piangere.
“Ecco che la sorte mi ha portato via una moneta d’argento[5]!” pianse tutto il giorno, ma la notte successiva la sorte fece ritorno per porre al posto della moneta d’argento una moneta d’oro. La sorte infatti fa così, è una ladra che ci ruba qualcosa, ma poi in poco tempo può renderci al suo posto qualcosa di più prezioso: non c’è da vivere temendo i tiri della sorte.
I bambini erano in piazza a giocare alla morra, Ulsio invece ascoltava il suo maestro, che strada facendo gli parlava di Socrate e Platone, mentre erano diretti all’Ara Pacis: il grande monumento eretto per celebrare la vittoriosa campagna di Augusto, nelle province occidentali: quando iniziò il periodo della Pax Romana. L’altare si avvicinava alla coppia che procedeva lenta. Ulsio pensava proprio alla tregua, mentre entrava nel Campo Marzio. In quell’epoca i barbari stavano forzando i confini e sarebbe cominciato un periodo di guerre e combattimenti.
“Come vorrei sognare la pace!” disse Ulsio. Intanto l’Ara Pacis era davanti ai suoi occhi, recintata da un grande rettangolo di oltre 10 metri per lato. Il monumento recava stupende decorazioni: figure femminili sullo zoccolo, scene di vestali come fregio superiore, la figura del Pontefice Massimo. Nella parte inferiore bellissimi acanti, in quella superiore un ricordo della lupa di Romolo e Remo.
“Devi sempre anelare alla pace!” disse Tigillio.
“Ma è un’utopia!” rispose il giovane romano.
“Con le utopie l’uomo è andato avanti. Spera sempre, immagina un mondo di fratelli nella tua fantasia e tutto ti sembrerà più bello!” continuò l’insegnante greco.
“Tuttavia rimarrà pur sempre immaginazione!” ribatté l’allievo, ma il maestro narrò una favola per far capire quanto la capacità di fantasticare aiuta poi i progetti a concretizzarsi:
I FIORI INCANTATI
Por aveva una eccezionale fantasia. Nella sua cameretta, che era anche il suo personale regno, giocava vagando con l’immaginazione e sognando.
“Galoppa oh mio destriero!” diceva dolcemente sul suo cavallo a dondolo e pensava di andare veloce per brughiere e colli verso il castello reale. Il cane di peluche lo pensava come il suo fedele guardiano, tanto che lo sentiva abbaiare.
“Caro fido amico!” gli diceva cogliendo un barlume di vita nei suoi occhi di porcellana. Ogni tanto prendeva dall’armadio una coperta e fingeva di montare una tenda indiana, poi pigliava il cavallo e sognava di correre per il bosco.
“Mi fermerò in questa parte della selva!” disse. Smontò dal cavallo a dondolo e immaginò di trovare rose selvatiche: ne colse un grande mazzo, indi cambiò gioco. Prese il teatrino arancione con le marionette. Dava vera vita ai burattini, li faceva a parlare e dialogare. Giunse la sera. Aveva giocato tutto il pomeriggio.
“Ma era solo fantasia…!” disse malinconico, quando si rese conto di aver legato alla cintura ancora il bel mazzo di rose selvatiche colte nel bosco della fantasia, corse in cucina e le regalò alla mamma.
Il Diritto Romano, ovvero l’ordinamento giuridico del popolo della città a capo dell’impero, partendo dalla famosa Legge delle Dodici tavole, aveva codici e norme che saranno poste alla base del diritto per centinaia e centinaia d’anni. Ancora nell’XI secolo, la principale fonte per avvocati e uomini in toga, erano le leggi romane. Nel 1100 lo studio sistematico in fatto di codici, alle Università di Bologna e Pavia, erano i libri delle leggi dell’impero[6]. Importanti norme per cittadini, dai senatori ai plebei, ma soprattutto si sottolineavano le norme vigenti riguardo al matrimonio. Ulsio era assai incuriosito sulle relazioni tra matrona e marito, ma più che altro si chiedeva:
“Che cos’è l’amore?”
Il suo maestro gli spiegò che l’amore vero è godere nel sacrificarsi per la persona amata e gli raccontò la favola sul marinaio triste:
IL MARINAIO TRISTE
Un prode marinaio, affrontando marosi e cavalloni, un giorno vide la propria barca colare a picco. Egli fu risucchiato da un vortice tremendo. Un impetuoso mulinello d’acqua lo trascinò sul fondo. Andò giù per centinaia di metri, fino a quando sotto all’oceano, si ritrovò nel regno della principessa Atlanta. Atlanta possedeva un reame in fondo al mare: c’erano coralli, pesci, conchiglie. Tutto era proprietà della principessa.
Atlanta s’innamorò del marinaio.
“Ti sposerò!” disse e lo prese come marito.
Il tempo trascorreva. Il marinaio stava bene in quel regno incantato. La principessa lo amava molto ma il marinaio, in cuore, aveva una grande nostalgia del suo paese, degli amici, la mamma e il babbo.
“Come vorrei tornare sulla terra!” diceva sconsolato e afflitto.
Intanto i marinai suoi compagni, lo andavano cercando affrontando la profondità degli abissi, ma la principessa lo nascondeva.
“Sono troppo innamorata per lasciarti tornare a casa!” diceva Atlanta.
Il marinaio però diveniva sempre più angosciato.
“Io ti amo davvero e prima ancora della mia felicità voglio la tua!” decise la bella Atlanta, che per amore lo fece risalire in superficie dove i suoi compagni marinai lo ritrovarono e in gran festa lo riportarono a casa. Quello fu amore vero.
Eccezionale fu la costruzione dei romani in quanto a strade. La penisola era collegata ai territori d’oltralpe; la via Appia univa la capitale alle Puglie; per andare nella pianura Padana c’era la via Aemilia. Le ampie carreggiate erano composte di strati di pietrisco, ghiaia, sabbia, su cui era posta la pietra in basalto.
Roma era trafficata da commercianti e non si faceva uso delle vie solo ad uso militare. In quel periodo iniziava anche l’attività dei corrieri postali.
In un pomeriggio autunnale, Ulsio e il suo maestro greco camminavano per la via Salaria, quella destinata al trasporto del sale.
Nella strada passavano mercanti e carri, a un certo punto transitarono credenti nei culti misterici. Erano tantissime le religioni dell’antica Roma. Il maestro decise di narrare una favola sulla religione.
IL RIPOSO DEL GIORNO DI FESTA
Si avvicinava la mezzanotte del giorno di festa. Il sacerdote preparava i fedeli:
“Dovrete astenervi dal lavoro per onorare gli dei!” diceva dal pulpito.
Era infatti vietato lavorare nel giorno di festa. Si stavano preparando ceri votivi e già si cantava rivolti a Zeus.
Il buon Pin trovò sul percorso un ferito bisognoso di cure, mentre ormai la sera era calata e la mezzanotte continuava ad avvicinarsi.
“Aiutami oh buon uomo!” supplicò il bisognoso a Pin.
Pin non avrebbe fatto in tempo a portare il ferito in città e curarlo prima dello scoccare della mezzanotte e non sapeva proprio come fare. L’uomo sanguinava copiosamente e Pin voleva aiutarlo con tutto il cuore.
“Non posso lasciare quest’uomo senza soccorrerlo!” si diceva, ma aveva anche paura di contravvenire ai dettami religiosi.
“Profanerai la festa!” gli dicevano gli altri, ma il Mago dei Maghi apprezzò assai la generosità di Pin, mosse la sua asta fatata e recitò:
“Abradrum abradram!” e così allungò il giorno di molte ore, cosicché la mezzanotte arrivò solo dopo che il ferito fu portato in città e curato[7].
Spettacoloso era vedere le legioni partire per le imprese militari. Le centurie formavano truppe di 100 (poi 80) guerrieri. Nella legioni figuravano cavalieri e fanti, disposti in manipoli strategicamente studiati. I combattenti si sarebbero schierati su tre file, armati di lance e spade.
Un’insegna veniva portata come guida della truppa e c’era un grande spirito di corpo. Tutti i combattenti erano disposti a lottare per la patria, non avevano paure né tema. Nel periodo imperiale bellissimi elmi venivano portati dalle truppe: c’erano elmi per centurioni, elmi per ausiliari, elmi da cavalieri. Splendide le armature a piastre con robusti scudi, archi e frecce.
Erano tutti pronti a difendere i confini.
“Ma non hanno paura della morte?” chiese Ulsio a Tigillio.
“Essi hanno in cuore la voglia di proteggere le frontiere! Non temono!” rispose il maestro e raccontò:
LA VITA
Numidio non riusciva a vivere, pensava solo alla morte.
“Ho tanta paura di morire!” si lamentava, così tappava le finestre di casa, abbuiava la stanza e si copriva la faccia per proteggersi da ogni male. Non faceva niente nella sua giornata, la sua esistenza era così, priva di ogni senso, non c’erano passeggiate, mancavano le imprese, non anelava ad alcunché.
Più tempo passava e più Numidio provava tristezza. Le ore trascorrevano lente e senza colore.
“Ho paura di morire!” continuava a dire, ma la sua maniera di campare era tanto priva di ogni emozione, che la mestizia lo assaliva.
Un giorno si fece coraggio e aprì leggermente la finestra. Entrò un raggio di sole magico. La polvere era illuminata da quel bagliore. Il raggio di sole rischiarò tutta la stanza di luce viva e comparve la voglia di vivere e essere attivi, che disse:
“Non aver paura di morire, ma dello squallore della vita!” e da quel giorno Numidio cominciò a vivere intensamente e con tutto sé stesso, senza più pensare alla morte ma assaporando ogni sua impresa con cuore e ardore.
Ulsio era un bambino dai sentimenti davvero speciali. Il suo maestro lo stava educando con le belle letture dell’antica Grecia, quelle che narravano di democrazia e possibilità del popolo di partecipare alla grande assemblea che nell’agorà[8] prendeva le decisioni, egli amava la fratellanza e l’amicizia.
“Vorrei essere amico di tutti!” diceva Ulsio all’insegnante mentre con un libro di Talete procedevano lungo il viale. Talete narrava di origine della materia e di creazione del mondo.
“C’è un principio, che Talete di Mileto chiamava ‘arché’ che sta ai primordi d’ogni cosa!” commentò Tigillio scorrendo le righe dell’antico filosofo.
“Secondo me alla base di tutto c’è l’amicizia!” rispose il piccolo, allora Tigillio gli narrò:
I DUE AMICI
Anus e Pecus erano due grandi amici, si volevano bene come fratelli e ciascuno avrebbe dato qualsiasi cosa per la felicità dell’altro.
Un pomeriggio, mentre il sole tramontava, Anus guardava la sua vigna. Era piena di acini maturi e l’uva era copiosa tra i filari.
“Sarà per me grossa rinuncia, ma voglio regalare tutti questi frutti al mio amico del cuore Pecus!” decise Anus.
Così attese la notte, prese tanti tini e li colmò d’uva.
“Adesso porterò tutto nella cantina del mio amico!” pensò tra sé e sé.
Con rammarico offrì tutta quell’uva al compagno, ma sapeva che mettere a disposizione di Pecus quei grappoli zuccherosi gli avrebbe regalato grande gioia in cuore.
Nelle stesse ore, però, anche Pecus dopo aver rimirato la propria vigna, si era deciso a fare anche lui dono di tutti quei prodotti ad Anus. Così mentre le tenebre erano calate sui loro poderi, egli si dirigeva alle cantine del suo caro fraterno compagno per colmarlo di doni.
Quando la mattina entrambi si svegliarono e si recarono nelle rispettive cantine, trovarono tutti e due uva in quantità: l’amicizia è davvero una gran cosa.
Il numerosissimo popolo sprovvisto di privilegi, nell’antica Roma, era la plebe. Mentre i patrizi vivevano nella ricchezza, essi erano assai poveri. Piano piano però, si affermarono i tribuni della plebe, ovvero l’istituzione che li difendeva per livellare il divario.[9]
“Il patrizio non deve essere egoista!” spiegava per educarlo Tigillio a Ulsio e gli narrò una favola:
IL BAMBOLOTTO FATATO
Pat era bambino assai avido ed egoista, esoso e ingordo: non dava mai niente a nessuno. Un giorno gli regalarono il bambolotto magico. Era un pupazzo di paglia e panno ma aveva due occhi come rubini.
“Voglio oro!” diceva Pat e il bambolotto magico gli donava oro.
“Voglio giocattoli e zaffiri!” chiedeva il bambino egoista per essere così esaudito. Aveva la stanza piena di cose preziose, giocattoli e soldi, ma non era disposto ad offrire nulla al prossimo. I fanciulli miseri stavano per la via supplicando un tozzo di pane secco. Lui non aveva cuore per gli altri e custodiva gelosamente ogni suo bene. Chiedeva e chiedeva al bambolotto incantato e mai era pago né contento: accumulava senza amare nulla di ciò che aveva. Una volta chiese al pupazzo dagli occhi di rubino:
“Voglio andare all’avventura per cercare il gran tesoro!” e si ritrovò su una nave con la prua a forma di bisonte, in mezzo all’oceano alla volta dell’isola del tesoro. Purtroppo, nel mare infinito, le onde cominciarono a divenire sempre più grandi e violente ed egli naufragò con il pupazzo che si era inzuppato tutto e non funzionava più. Pat non poteva più tornare a casa e piangeva. I marosi lo portarono fino all’isola, un blocco di terra ampio e verdeggiante dove viveva una popolazione assai generosa. Gli indigeni si comportavano con magnanimità e gentilezza verso il prossimo. Una volta approdato, Pat seppe però che i nemici dell’isola accanto, avevano rapito e imprigionato la figlia dello stregone. Pat venne preso da un impeto di generosità. Salì su una palma e scorse la capanna dove la ragazza era nascosta. Con tutto sé stesso, si lanciò alla salvezza della giovane. Lottò contro un orco e un gigante e tutto il popolo rivale, mettendo in gioco per generosità la propria vita.
La figlia dello stregone venne portata in salvo.
“Esprimi qualsiasi desiderio!” gli disse lo stregone che voleva premiarlo.
“Voglio tornare a casa!” chiese Pat.
Lo fecero salire su un tappeto magico, misero con lui il tesoro dell’isola e Pat fece ritorno alla dimora paterna, dove abbracciò i genitori e da quel giorno fu generoso, offrendo gran parte dei suoi giochi e dei suoi averi ai bambini poveri.
Per celebrare la vittoria di Costantino contro Massenzio, era da poco stato costruito un arco trionfale proprio vicino al Colosseo. Era un’opera su piloni di marmo, la sua forma era quadrata. Nell’arco di Costantino erano istoriate scene dell’esercito, figuravano tutti i ‘buoni imperatori’ del secolo precedente, si vedevano battaglie contro i nemici, ora i Quadi ora i Marcomanni, c’erano raffigurate cacce all’orso, al cinghiale, al leone e non mancavano le immagini riferite al sole-apollo sulla quadriga. Erano scolpiti significativi episodi di guerra, fino alla celebrazione dell’imperatore.
“Come vorrei anche io essere un aggressivo combattente!” disse Ulsio mentre scorgeva le immagini.
“Non serve solo l’aggressività nella vita!” gli rispose Tigillio e cominciò con una favoletta:
IL SEREPNTE OPHIS
C’era una volta un tremendo serpente dalle cento teste di nome Ophis. Era mostruoso con tutte quelle facce orribili e bavose, custodiva i pomi aurei che davano felicità al popolo.
“Voglio, per celebrare le mie nozze, le mele d’oro custodite dal serpente Ophis!” disse il re prima del suo sposalizio, voleva egli regalare la pace al suo regno e la gioia di vivere.
Partirono guerrieri e prodi paladini per sconfiggere il serpente dalle cento teste e portare i pomi d’oro al re, ma tutti rimanevano vinti. Il serpente avvinghiava tra le sue spire i combattenti, oppure li divorava con le sue fauci tremende.
In mezzo all’oceano, Ophis, se ne stava padrone della sua isola a rimirare i pomi d’oro, aveva fatto il buio intorno a sé. Presso l’isola non sorgeva più il sole e le tenebre della cattiveria impedivano di vedere, a chi voleva prendere le mele magiche.
L’umile Pig decise di provare; egli era ragazzo che in cuore aveva tanto amore e voleva esaudire i desideri del monarca.
Non si munì d’armi, ma solo del suo spirito e della voglia di riuscire.
Mentre si avvicinava all’isola in mezzo all’oceano, le tenebre lo avvolsero, tuttavia l’amore che aveva in petto fece gran luce. La notte venne sconfitta da quel sentimento e fu chiarore dappertutto. Un grande albero fu illuminato, in esso nascevano i pomi magici, Pig accecò con i bagliori del cuore il serpente e prese tutte le mele d’oro, le recò al re e fu gran festa, con la celebrazione di uno storico matrimonio e la pace che arrivò a rasserenare la vita di tutti.[10]
Nella vita giornaliera dell’antica Roma la famiglia aveva ruolo fondamentale e importantissimo. Il Pater Familias e la matrona erano assai attenti all’educazione della prole e l’unione tra coniugi era considerata l’istituto umano fondamentale.
“Un giorno, anche io vorrò avere una bella casa e dei figli!” diceva Ulsio immaginandosi simile al padre.
“Ci vorranno innanzitutto tanto bene e amore!” commentò in quel mattino assolato, nell’atrio della casa familiare, il maestro Tigillio. Intanto il padre di Ulsio officiava agli dei, augurandosi una buona crescita per il suo piccolo, egli aveva piena potestà sul figlio, ma anche tanta responsabilità:
LA FAMIGLIA DI GIUS E BIANCA
C’era una volta una coppia che attendeva da anni e anni almeno un figlio. Erano assai agiati e generosi, nella loro domus non mancava nulla: c’erano belle fontane, ricche statue in onore di Cecere e Nettuno, avevano centinaia di schiavi al loro servizio, ma mancavano le risa di un pargolo e lo sgambettio di un giovane virgulto a rallegrare le giornate e riempirle d’amore.
L’uomo si chiamava Gius, era persona assai corretta e trattava gli schiavi da pari a pari, rispettando la dignità di ognuno, però viveva compiangendosi:
“Siamo tanto ricchi ma non potremo mai avere un erede!” diceva poggiando il capo tra le mani e con i palmi tra i capelli.
“Come vorrei cullare e allevare un piccolo!” soffriva la moglie Bianca, che aveva necessità di dare sfogo al suo amore materno.
Un giorno, un viandante bussò all’uscio della loro casa. Essi erano così pieni di buoni sentimenti e di capacità di donare il proprio cuore, che lo ospitarono, offrendo nettare come bevanda e anatra all’arancio per pietanza. Per lui fu preparato un comodo letto, lo fecero lavare e rivestire con tuniche preziose e importanti, ma soprattutto lo confortarono con dolci parole.
“Per tre mesi mi avete ospitato come fossi un nababbo anziché un misero viandante. Me ne vado ringraziando e lasciando a Bianca questa melanzana! Aspetta la luna piena e mangiala e dopo nove mesi avrai in premio una sorpresa!” disse il pellegrino dopo aver trovato accoglienza per un trimestre intero.
Bianca attese la notte di plenilunio e mangiò la melanzana. Grande festa fu celebrata dopo nove mesi quando nacquero due biondi gemelli belli e paffuti: un maschietto e una femminuccia.
L’amore che avevano in cuore Gius e Bianca venne premiato da quel fantastico prodigio.
Dopo l’impero di Nerone, soprannominato Barba di rame, continuavano le persecuzioni dei cristiani. I fedeli di Cristo erano stati arsi vivi nell’arena, erano stati fatti sbranare in pubblico dalle belve e persino crocifissi nei giochi pubblici.
Ulsio aveva sentito narrare di questi cristiani, orgogliosi e credenti, essi, pur perseguitati, riuscivano a trovare la forza di vivere con speranza e gioia.
“La voglia di vivere è fondamentale!” narrava nella stanza di studio il maestro Tigillio, poi iniziò con una favola:
LA VOGLIA DI VIVERE
Il ricco sultano Trad non aveva più voglia di vivere. Con gli occhi cupi e le labbra storte, gemeva e si lamentava:
“Quale tedio è campare!”
Ogni cosa era per lui angosciosa e i suoi sudditi facevano di tutto per guarirlo.
C’erano giullari che si presentavano innanzi a lui per esibirsi, ballerine che danzavano, comici che lo intrattenevano, ma nulla serviva per rincuorarlo e dargli energia.
Lo portarono allora sulla nave del fiume e lo imbarcarono. Per giorni e giorni il battello seguì il corso della corrente. A un certo punto si trovarono innanzi allo scoglio magico.
“La mia esistenza è nera!” continuava a compiangersi Trad, che ormai non mangiava neanche più, il suo viso era emaciato e l’espressione spenta.
Dallo scoglio emerse la sirena Imeropa[11]. Il suo era un canto fatato che suscitava la voglia di vivere in chi l’ascoltava. Note meravigliose furono udite da Trad. La voglia di vivere e il desiderio di rinascere entrarono nel suo animo. Trad cominciò con il mettersi dalla posizione supina in quella eretta, poi iniziò a ballare e fare cose, ridere e scherzare.
“Ho tanta voglia di vivere!” gridava invitando i lacché a suonare i flauti e battere i tamburi a festa e da quel giorno non fu più triste.
Ulsio era assai appassionato dai cavalli delle corse sulle bighe. Chiese al maestro di accompagnarlo a mirar le scuderie. I cavalli avevano nomi curiosi e appassionanti, come Valente o Vento. Erano stupendi destrieri, accuditi con ogni cura e dalla muscolatura possente. Camminando vicino alle stalle si respirava un fragrante profumo di fieno, ma soprattutto, i cavalli venivano alimentati con cibi proteici e venivano loro somministrate potenti pozioni.
Ulsio li vedeva allenarsi nella pista in sabbia, con le vene a fior di pelle per lo sforzo e la voglia di dare all’auriga tutto il cuore:
“Che animale generoso è il cavallo!” decantava gli equini il piccolo romano, commentando la loro grandezza d’animo.
“Gli animali hanno sempre la capacità di ripagare chi offre loro cure!” rispose Tigillio per poi narrare:
IL CALDO NEL DESERTO
Una volta, nel lontano oriente, Luk curò l’uccello dall’ala spezzata, gli fasciò e steccò l’arto pennuto, per poi cibarlo e dissetarlo per giorni, fino a che il volatile non si riprese e poté tornare a librarsi nell’aere.
Luk era un modesto contadino, abituato a lavorare nelle risaie. I potenti del paese sopraffacevano gli umili e i deboli, così egli venne accusato ingiustamente di aver rubato, pur essendo leale, probo e onesto.
“Che sia lasciato a perire per tre giorni nel deserto!” fu la punizione per Luk.
Così, legato ai polsi e alla caviglie, venne lasciato nell’arido suolo sabbioso, a sfinirsi sotto l’arsura inclemente del sole.
Luk stava arrivando al limite. Le labbra erano ormai secche, l’umidità nell’aria del tutto assente, mentre i raggi dell’astro del giorno picchiavano forte e lui entrava in agonia. Crollò a terra senza più speranze, quando l’uccello da lui curato,
grato e non dimentico dell’opera di Luk lo vide. L’uccello chiamò tutti i suoi amici. Un enorme stormo volò in cielo e si piazzò sopra a Luk per fargli ombra e proteggerlo dal sole.
Esso resisté così al caldo atroce, fino alla fine dei tre giorni.
“E’ un essere magico!” gridarono tutti nel vederlo sopportare così a lungo il sole del deserto. Luk venne ritenuto una creatura fatata e nessuno lo accusò mai più ingiustamente di furto.
Le scuderie dei cavalli da corsa erano proprio di rimpetto ai terreni lavorati dagli schiavi. Non era tanto la condizione di non cittadino, che colpiva l’animo di Ulsio nell’osservare gli schiavi all’opera, quanto il loro mestiere, duro e con la schiena china. C’erano infatti anche liberti e salariati, tutti a faticare.
Al piccolo romano scappò detto:
“Che lavoro infimo!” ma il maestro lo riprese subito:
“Niente affatto!” commentò il greco Tigillio prendendo in mano un quadernino e leggendo una fiaba:
UN MESTIERE DURO
I nobili se ne stavano tutto il giorno a gozzovigliare, pettinarsi e fare libagioni.
“Abbiano in grande sprezzo i contadini!” dicevano, sentendosi a loro agio solo seduti a mensa, a divorare cosciotti d’agnello e bere forte vino.
Stare a tavola li faceva ingrassare e alla lunga li annoiava, tuttavia continuavano a disdegnare coloro che vangavano e zappavano, al lavoro tutto il giorno, sotto il sole o con il cattivo tempo.
Proprio quel dì di primavera, mentre i coloni erano intenti a preparare i campi per la semina, avvenne un fatto straordinario.
I nobili cercavano di trovare la felicità e la soddisfazione in brindisi e scorpacciate, l’ozio però li rattristava sempre più mentre Cerere, la dea delle messi, compì un miracolo in premio ai lavoratori.
Il cielo si tinse di colori luminosi, il sole offriva raggi incantati. I semi appena deposti dai contadini si svilupparono precocemente. In ogni piantina che cresceva si vedevano e si potevano assaporare la vita e l’energia. Presto il grano fu maturo e gli alberi erano colmi di bacche e frutti speciali. Ogni albero pareva che parlasse e cantasse stornelli d’amore e ringraziamento a chi li aveva curati.
“Evviva!” festeggiavano soddisfatti i contadini, mentre dalle loro terrazze i nobili guardavano stupefatti e anche un po’ invidiosi.
La dea Cerere apparve sulla cima del monte che stava davanti ai campi coltivati e sentenziò:
“Chi lavora la terra non è infimo: è invece il terreno la casa più ricca del mondo, perché ogni frutto nasce da essa!”
La capitale, nonostante il declino dell’impero, continuava a essere luogo vivo e stracolmo di gente. Roma Caput Mundi era assai animata e da essa dipendevano ancora, tutti i paesi affacciati sul Mediterraneo, oppure al di là delle Alpi Francia e poi a est Turchia e Grecia. I cittadini romani non si rendevano conto del loro ruolo d’importante esempio per tutti. Nell’urbe spesso si bighellonava e molte volte si sragionava:
“E’ tipico della gente sragionare!” spiegò Tigillio a Ulsio e poi raccontò:
IL MATRIMONIO
Al banchetto di matrimonio partecipava tutta la città: c’erano soprattutto i ricchi e i nobili, che tra ori e gioielli, con le loro belle tuniche color porpora e gli schiavi a far loro vento, se ne stavano comodi distesi sui triclini[12].
“Bevete questo vino di Frascati!” invitava lo sposo.
Mentre tutto ciò accadeva, Gefo, scapolo da anni, guardava con invidia i novelli consorti. La sposa era bellissima, Gefo la osservava tristissimo, sognando anche lui una moglie, doveva accusare qualcuno per come gli erano andate le cose nella vita:
“Maledizione!” non capiva che era stato lui stesso a farsi terra bruciata intorno, non comprendeva che era stato lui a rifiutare di aprirsi, di dare il suo cuore.
Gli altri ballavano e si davano alla gioia, festeggiando l’evento.
Gefo era tuttavia sempre più arrabbiato. Mentre gli altri assaporavano frutta e bevevano, lui rifiutava ogni cosa e brontolava.
“E’ colpa tua se quando da giovane ho conosciuto la bella Elena non mi sono sposato!” cominciò a dire al piccolo Bibo… ma Bibo all’epoca di quegli eventi non era neanche nato.
Troppo spesso le persone anziché ragionare, quando devono dare la colpa delle proprie pecche a qualcuno perdono la testa.
Vennero serviti grappoli di splendida uva, Gefo vide riflettere il proprio volto su un chicco d’uva fatato, si vide nella buccia del frutto e osservò quanto sciocco era.
Per le strade di Roma era un gran via vai di gente e carri: di giorno le persone e di notte i barrocci. Si beveva alla taverna, si vociava, c’erano plebei, uomini d’affari, filosofi e artisti, anche stranieri, richiamati dalla capitale. Ulsio assisteva a quella vita. La gente non si vergognava mai né di ridere né di piangere. Il piccolo invece, nonostante la giovane età aveva mille remore prima di esternare i propri sentimenti e il suo insegnante avrebbe voluto aiutarlo a riuscire a mostrare, più palesemente, i suoi sentimenti; così mentre camminavano tra gli splendidi monumenti di Roma[13], Tigillio principiò una favola:
IL RAGAZZO SENZA EMOZIONI
Nimo si vergognava a mostrare sorriso o pianto, il suo viso era sempre immobile, attento a non far vedere al prossimo quali sentimenti provasse.
Con i denti serrati procedeva a piedi verso la piazza. I compaesani sorridevano o erano tristi a seconda dell’umore, degli eventi, dei casi.
“Io non voglio né piangere né ridere!” diceva nella sua mente Nimo.
Passarono i guerrieri diretti alla frontiera, armati e pronti a combattere. Versavano lacrime le loro madri, mostrando gran dispiacere. Cantavano e inneggiavano i popolani, manifestando la loro partecipazione alle lotte dell’esercito.
L’alfiere che recava lo stendardo, marciava innanzi a tutti. Sullo stemma era ben disegnata un’aquila reale.
Nimo era l’unico a rimanere impassibile. Nell’animo sentiva però emozione. Anche lui provava accesi sentimenti, vedendo tra i guerrieri il fratello maggiore andare protetto da elmo e scudo verso il fronte.
Avrebbe voluto urlare ed incitarlo, augurargli buona fortuna, ma si vergognava. Un raggio di sole si specchiò sullo stendardo che raffigurava l’aquila bicipite, il rapace prese vita agli occhi di Nimo, volò verso di lui e gli disse:
“Il giovane che non ha mai pianto è un selvaggio e il giovane che non ha mai riso è uno stolto!”
Nimo cominciò allora a dare dimostrazione concreta di ciò che provava.
Iniziò a esortare il fratello a tirar fuori coraggio e ardore.
Da quel giorno mai più ebbe soggezione di ridere al momento opportuno, o di sfogare la propria angoscia.[14]
Come ogni alba, Ulsio si era alzato. Aveva mangiato pane e formaggio, mentre il babbo era già pronto per cominciare i suoi affari e la sua mamma si preoccupava di ordinare ai servi il pasto della sera:
“Struzzo e ricci di mare!” chiese la matrona come piatto principale.
Ulsio mise nella cartella pane e miele e poi Tigillio lo prese per mano e lo portò a prendere i quaderni, prima di affidarlo allo schiavo che lo avrebbe accompagnato a scuola.
“Penso ai poveri di Roma, alla loro sofferenza!” disse Ulsio.
Il maestro gli rispose con una favola:
L’ALTA VISIONE
I ricchi del Paese credevano di avere un’ampia visione di tutto.
“Scorgiamo lontano!” si vantavano. Procedevano adornati di gioielli e con preziosi anelli alle mani, mostrando le loro carrozze tirate da splendide pariglie di cavalli ora morelli, ora bai o grigi.
Avvenne un giorno che le sentinelle annunciarono l’arrivo dei barbari dalla porta est. Era fatto giorno da poco e bisognava ben vedere quanto grande fosse l’orda degli invasori.
I ricchi osservavano ma non videro alcunché.
I poveri erano a penare, mille i patimenti e tante sofferenze.
Tra tutti il più sfortunato era Gunio, che soffriva dolori tremendi.
Gunio, affamato e infreddolito, essendo privo di ogni mezzo, di cibo e di coperte per ripararsi dalle intemperie, si appostò sull’alto monte.
Dalla sua situazione di sofferenza, riusciva a scorgere con chiarezza ogni cosa:
“Sono più di mille barbari, procedono con le armi in pugno e per respingerli servirà un’intera legione!” fu così che grazie alla capacità di Gunio di vedere lontano, i barbari furono respinti.
“Non c’è niente di più alto della croce della sofferenza e del dolore per contemplare il mondo e vedere lontano[15]!” commentarono i saggi del paese, mentre il popolo, ricchi e meno abbienti, offriva cibo e coperte a Gunio che si ristorò e scaldò.
Anche quella sera nella domus della casa di Ulsio si dava una gran festa. I patrizi erano distesi sui lettini[16], coricati sghembi e appoggiati sul gomito sinistro, mentre con la mano destra mangiavano senza posate, ricchi pasti. Tuttavia tutte quelle orge non davano vera gioia. Ulsio sapeva dei plebei che pur accontentandosi di pane e olive, riuscivano a provare gioia nello stare insieme.
“Non è il denaro che fa la ricchezza!” disse Tigillio al giovane romano e poi narrò:
IL PIU’ RICCO
C’erano una volta tre uomini nello sconfinato oriente. Il primo aveva tanti palazzi e terreni, il secondo tanto oro, il terzo non aveva nulla.
“Chi di noi è il più ricco?” chiese quello dotato di palazzi, mentre mostrava le sue ricchezze all’oracolo.
L’oracolo allora, dopo aver visto tutte quelle sontuose costruzioni volle sapere cosa avesse il secondo.
“Io ti mostro tutto il mio oro!” disse egli e portò ori in quantità enorme, tanto che tutto il pavimento di pietre innanzi all’oracolo, era cosparso di monete auree.
I castelli e i palazzi del primo uomo scintillavano sotto il sole, anche gli ori dell’altro erano stupendi.
Intanto il terzo uomo guardava triste. Lui era povero e già s’immaginava che la risposta dell’oracolo lo avrebbe fatto sentire misero e negletto.
L’oracolo sentenziò rivolto ai primi due:
“Avete davvero tanti beni!” poi si soffermò a pensare e quindi interpellò l’uomo povero.
“Tu cosa hai?” gli chiese.
L’uomo povero divenne rosso per la vergogna, abbassò gli occhi e poi rispose:
“Io non ho nulla, solo un grande cuore!”
“Tu sei il più ricco di tutti, infatti gli altri potranno vedere crollare i palazzi o potranno perdere l’oro; il tuo cuore invece non te lo potrà rubare mai nessuno!”[17]
Quando l’imperatore decideva di percorrere le vie dell’urbe, solenni erano i paludamenti dei quali si adornava. I pretoriani, ovvero le sue guardie personali, sfilavano muniti di armi possenti e con stupendi destrieri.
“Quanto sfarzo!” commentava Ulsio ammirando il corteo.
L’imperatore era davvero vanitoso, indossava un mantello color porpora sopra alla bianca tunica e aveva anelli assai preziosi alle dita. I suoi soldati, scelti dopo lunghe selezioni, erano i più coraggiosi e forti delle legioni, per svolgere il ruolo di guardia del corpo in maniera ottimale. Le guardie augustee arruolate erano più di mille:
“Il troppo sfarzo è debolezza!” commentò il maestro greco al suo allievo per poi cominciare con un racconto:
LO SFARZO DEL RE
C’era una volta un re tanto vanitoso. Egli si preoccupava solo di sfilare davanti ai sudditi mostrando la propria bellezza e il potere.
Quando scendeva in piazza era scortato da un numero infinito di protettori, tutti vestiti d’oro e con spade d’argento. Ogni mattina il sire si affacciava alla terrazza reale, mille e più trombettieri lo annunciavano, si pretendeva che il popolo si mettesse in ginocchio per adorare le ricchezze di corte e i tamburi suonavano solenni:
“Sono il più forte!” annunciava il re dal verone, al quale erano appesi splendidi drappi di damasco rosso, orlati da metalli preziosi.
“Inchinatevi!” ordinavano le guardie ai sudditi e la gente si doveva impegnare in salamelecchi e galanti inchini.
Tutti odiavano quella prosopopea del re, il popolo lo temeva e non lo amava.
Un pomeriggio, davanti allo specchio magico il re chiese alla superficie riflettente:
“I miei sudditi mi amano?”
“Non si può amare tanta prosopopea che è solo segno di debolezza!” rispose lo specchio magico.
Il re decise di essere meno plateale e mostrare meno sfarzo. Divenne umile per poter servire il popolo. La vanità sparì e il popolo iniziò ad amarlo.
L’imperatore continuava a offrire giochi e spettacoli al popolo: combattimenti tra gladiatori, belve tremende di provenienza esotica, sacrifici umani.
“Sarebbe meglio adoperare tutti questi soldi per fini migliori!” commentò un giorno il sagace Ulsio, ancora bambino ma assai acuto nei ragionamenti. Il dotto insegnante conosceva la storia delle etnie e dei paesi, decise quindi di narrare una favola orientale in attinenza al commento dell’allievo. I due camminavano proprio vicino a un anfiteatro, nel quale la sera stessa si sarebbe celebrato un nuovo spettacolo prestigioso e dispendioso… l’imperatore faceva di tutto pur di accattivarsi il favore del popolo:
LA GUERRA DEI GRILLI
Nell’antico oriente, al tempo dei Ming[18], quando le dinastie si adornavano di damaschi abbelliti da fili d’oro e le sete erano pregiate, si usava portare alla fiera i grilli.
Vinceva chi presentava il grillo più bello e poi lo faceva combattere contro gli altri.
Il magistrato di palazzo incaricò Fin di cercare il grillo più bello e potente, affinché vincesse la mostra e il combattimento.
Fin penava nel pensare ai soldi che avrebbe dovuto spendere e al cruento spettacolo della lotta del combattimento tra i grilli, che sebbene siano animali piccoli sono pur sempre creature viventi, dotate di cervello e cuore.
Fin andò comunque alla ricerca di quanto gli era stato richiesto dal magistrato.
Si alzava la mattina presto, girava per mercatini e fattorie, ma i grilli più belli costavano assai. Tornò dunque da chi lo aveva incaricato della ricerca e gli spiegò i fatti, ma il magistrato gli rispose:
“Se il grillo costa assai tu provvedi con tasse e gabelle che imporrai ai poveri, i soldi dei contadini ti basteranno.”
Fin non se la sentì di estorcere denari ai miseri lavoratori ma uno gnomo magico, per premiarlo di tanto pensiero per il prossimo gli regalò un grillo magnifico.
Il grillo vinse la mostra, in quanto aveva un aspetto reso fantastico dalla magia del bosco incantato.
Lo gnomo intervenne prima del combattimento e gridò:
“Bando alle ostilità! Io stesso, re del bosco, eleggo il grillo di Fin vincitore e il premio della mostra verrà donato ai poveri contadini che da anni provvedono a pagare con tasse e gabelle gli spettacoli dei potenti!” e almeno quella volta tutti fecero gran festa.
Ulsio rimaneva sempre affascinato nell’osservare i suoi coetanei plebei divertirsi con giochi poveri e semplici. Essi erano capaci di trastullarsi beatamente con carrettini trainati da topolini o colombe[19], con i dadi o misere bambole di terracotta. Inventavano giochi di destrezza coi sassi, erano insomma abili nel trovare divertimento e gioia in cose apparentemente senza valore, riuscendo a scoprire ogni miracolo della vita. Oltre a vivere gaiamente, tra essi c’era anche tanta felicità nello stare insieme.
“Ma come faranno?” commentava Ulsio mentre procedeva per le vie di marmo della bella città, accompagnato dal maestro greco. Tigillio rispondeva:
“L’esistenza è un percorso da ammirare!” e una volta raccontò:
LA STRADA DELLA VITA
Abro andava avanti nel suo percorso, la strada della vita, ma la sua via era sempre buia, priva di colori e triste.
“Il mio incedere è mesto e non vedo la luce!” si lamentava il giovane. Egli non riusciva a scorgere niente di degno nella sua esistenza e arrancava sempre più stanco.
Il cammino della vita può essere duro, se non si aprono sentimenti e cuore. Se Abro incrociava un compagno lo malediceva e continuava da solo. Mentre lui affrontava gli erti tornanti della crescita, il fauno dei fanciulli l’osservava. Inutile sprezzo nei confronti del prossimo e incapacità di bearsi delle piccole gioie della via, accompagnavano Abro. Il fauno comparve, coi suoi occhi gentili e le zampe caprine, innanzi al giovane fanciullo.
“Chi sei?” gli domandò Abro, sempre scostante nei confronti di chiunque e anche parecchio scortese.
“Sono colui che può ridestare il tuo spirito e aprirti gli occhi! Guarda con l’anima lo splendore della via: le belle piante, gli olivi, i fiori, le aquile che si scorgono lontano sulla vetta della giogaia, i colori della volta celeste, i compagni che puoi incontrare!”
Abro per la prima volta si fermò a mirare il paesaggio. Apprezzò le tinte del cielo, la leggiadria dei rapaci che sparivano dietro la nebbia attorno alle cime dei monti. Sentì il suo cuore aprirsi a chi passava per la via.
“Devi sempre procedere gustando ogni momento e rispettare il prossimo!” aggiunse il fauno e poi sparì.
Davanti ad Abro apparve un compagno, ma questa volta il giovane aveva capito il senso del cammino della vita, non lo maledì ma anzi gli porse la mano e insieme si unirono per continuare la strada l’uno accanto all’altro: tutto divenne colmo di luce.
Per tutto il periodo della sua crescita Ulsio continuò ad ascoltare le interessanti ed educative fiabe del maestro greco, che rimasero per sempre impresse nella sua mente. Egli divenne da grande un bravissimo tribuno, che si preoccupò di difendere il povero e il negletto. Proprio nelle ultime pagine di questo modesto libercolo narreremo la favola che Ulsio ricordò, vedendo il trionfo con il quale venne celebrato il ritorno dalla guerra di un prode generale. Un lungo corteo si dipanava nella via che portava al Campidoglio, sfilavano gli animali che sarebbero stati sacrificati, a capo delle file c’erano i magistrati e i musici che suonavano celebrando le città conquistate. Davanti a tanto sfarzo Ulsio pensò a una bella favola che Tigillio gli aveva narrato da piccolo per ispirarlo ad amare più la bellezza del cuore che quella di drappi preziosi e cose materiali:
I COLORI DEL MONDO
In principio tutto era acqua: una distesa piatta e triste priva di vita.
Le nuvole volevano rendere il pianeta meno mesto.
“Come faremo?” chiese la nuvola più bianca alle compagne, ma nessuna sapeva trovare la soluzione.
“Portiamo l’oro!” propose una delle nubi. Vennero recate collane dorate e monete. Tutto luccicava ma mancava ciò che rendeva davvero gaia l’esistenza.
Allora un’altra nuvola pensò di mettere sul palcoscenico zaffiri e brillanti, che però apparivano bui in quella situazione priva di sentimento e bontà.
Un vento cominciò a spazzare il cielo, le nuvole continuavano a studiare la soluzione. Si tentò così mettendo monili e anelli preziosi, ogni sorta di bene dovizioso e ricco venne portato sulla Terra ma tutto seguitava a essere simile a un antro privo di luce.
La nuvola bianca vide cadere una foglia. La foglia verde galleggiava sull’acqua. A niente erano serviti tutti quei rimedi perché mancava il cuore. Una dolce brezza soffiò sulla foglia. Era il vento lieve della tenerezza. Con la tenerezza giunta nel pianeta sbocciarono miriadi di fiori, tutto si fece colorato e bello, in una fantasmagoria di sfumature e dolci melodie che uccellini nati per miracolo cantavano davanti alla celebrazione dei sentimenti buoni.
NOTE
[1] I numi erano le divinità in cui si credeva
[2] Lari e penati erano modi per indicare le divinità
[3] Si tratta di filosofi, il primo romano, gli altri greci
[4] Spiegato in termini moderni le insulae sarebbero i quartieri della plebe
[5] Cfr ispirato a Francesca Lazzarato, L’esilio di re Salomone, Mondadori, Milano 1994
[6] Cfr encarta dvd
[7] Cfr Francesco Lazzarato, L’esilio di re Salomone, Mondadori, Milano 1994
[8] Agorà: piazza della polis greca nella quale il popolo si riuniva a parlare e discutere n democrazia
[9] Cfr www.italiadonna.it
[10] Cfr Kòroly Kereneyi, Gli dei e gli eroi della Grecia, Fabbri editori, Milano 2005
[11] Cfr Karoly Kerèny, Gli dei e gli eroi della Grecia, Fabbri editori, Milano 2005
[12] Triclinio: il triclinio è il letto sul quale gli antichi Romani si distendevano per pasteggiare.
[13] Bombarde Odile, Vivere nella Roma Antica, Edizioni E. Elle, Trieste 1988
[14] Cfr Gianfranco Ravasi, www.avvenire.on-line
[15] Cfr Monsignor G.Ravasi
[16] Odile Bombarde, Vivere nella Roma antica, Edizioni E.Ele, Trieste 1988
[17] Balulì Zanà, Leggende del popolo curdo, Fabbri editori, Mlano 2001
[18] Cfr Moss Roberto, Fiabe e storie cinesi, Fabbri editore, Milano 2005
[19] Cfr Odile Bombarde, Vivere nell’antica Roma, E.Elle editore, Trieste 1988
[i] Cfr www.italiadonna.it
[ii] Cfr Monsignor Gianfranco Ravasi, www.avvenire.it
[iii] Cfr www.homolaicus.com
[iv] Giovanni Caselli, a cura di, Gli antichi romani, Giunti Marzocco, Firenze 1990
[v] Cfr www.ostia-ostie.net
[vi] Simon James, Roma Antica, De Agostini, Novara 1991
[vii] Cfr monsignor Gianfranco Ravasi, in www.avvenire.it
[viii] Cfr www.homolaicus.com
[ix] Giovanni Caselli, Gli antichi romani, Giunti Marzocco, Firenze 1990
[x] Cfr Alba Marcoli, Il bambino nascosto, oscar Mondadori, Milano 2003
[xi] Proverbio italiano

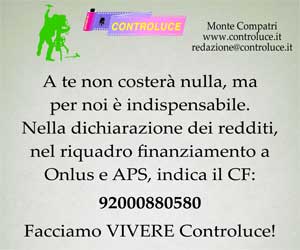



-ban.jpg)















































































































































































Non ci sono commenti, vuoi farlo tu?
Scrivi un commento