La scuola degli idioti, di Marco Onofrio

Piero Chiara soleva ripetere che scrivere un bel racconto è più difficile che scrivere un bel romanzo. Il racconto è sintesi e misura, arco teso che permette alla freccia di andare al bersaglio senza sbavature. Ma l’Italia letteraria continua ad essere refrattaria agli scrittori di racconti e le case editrici rifiutano di pubblicarli perché, dicono, non si vendono (come se i brutti romanzi si vendessero!), e perché non appassionano. Però quest’anno l’Accademia di Svezia risponde indirettamente a questo pregiudizio assegnando il Nobel a una scrittrice di racconti brevi, Alice Munro.
Può essere l’avvio per un mutamento di direzione? Nella grande tradizione del nostro Paese il racconto è capolavoro fulgido e limpido, con esempi lampanti che vanno dal Novellino a Boccaccio, a Masuccio Salernitano, a Sacchetti e, nel Novecento, da Pirandello ad Alvaro, da Bontempelli a Soldati, a Chiara, a Landolfi, per fare soltanto qualche nome. Comunque, incurante delle mode e delle occasioni, Marco Onofrio pubblica, con La scuola degli idioti (Ensemble edizioni, 2013, pp. 140, Euro 15), un libro di racconti che hanno un piglio molto particolare: fuori dalle assuefazioni, liberi assolutamente, sia nelle espressioni, sia nel linguaggio e nei temi. Non si è posto una barriera, un limite, un tema entro cui cincischiare o sostare ossessivamente, ma ha ribaltato i termini andando verso una forma eclettica che investe le ragioni più intime della sua scrittura e gli dà quella precisa facoltà di interpretare il sociale da una angolazione insolita. Per poter comprendere fino in fondo l’operazione messa in atto dallo scrittore bisogna un attimo soffermarsi a descrivere la qualità del suo carattere, il magma di entusiasmo e di cultura che egli è, l’irruenza che lo determina e lo spinge all’agone. Un agone che ha perfino tinte donchisciottesche e alla Rabelais, ma che poi si piegano all’ansia carezzevole del poeta per trovare una soluzione che non trascuri le segrete scaturigini da cui nascono le storie. Onofrio è un impasto di leone, di orso e di lupo famelico, che però ha lasciato la ferinità all’umore per farsi, di volta in volta, messaggero di valori. Infatti nei suoi percorsi c’è una disponibilità umana a comprendere ciò che muove le azioni, da far pensare a volte a filosofi come Montaigne o Pascal. Sì, un’ansia etica di forte tempra che si sparge nelle pagine e le irrora di quel fulgore celestiale che rende il tutto opera da godere, certamente, ma anche da meditare a lungo. Gli esempi in questi racconti sono a ogni pie’ sospinto eppure non ci sono pesantezze o noie nel leggerli, perché egli vola e fa volare, descrive l’animo dei protagonisti a presa diretta, spesso fino a far trionfare la vita sulla letteratura. Marco Onofrio è arrivato a sapersi districare come un Chesterton affinato e diffidente, godereccio, allegro, ridanciano, che tuttavia non riesce a trattenere l’indignazione quando, e proprio quando, il ritmo narrativo si fa intenso e accattivante. In questa maniera i racconti diventano sintomo vivo della realtà di tutti i giorni, anche laddove prendono la strada del surreale, del favoloso, dell’incredibile. Lo scrittore non si abbottona e non si astrae da ciò che sta scrivendo e, di conseguenza, fa sentire le vibrazioni calde della creazione. Avendo egli alle spalle ormai tantissime esperienze (critica letteraria, poesia, narrativa, giornalismo, saggistica), non trova difficoltà a saper maneggiare l’ironia e la tenerezza, l’assurdo e il reale, il piccone e la nuvola; e gli esiti sono sempre felici, grazie anche alla duttilità degli strumenti espressivi che realizzano limpidezza di immagini, scansione calibrata e visionarietà affascinante nei momenti più inaspettati. Prova ne sono le conclusioni dei racconti e l’amaro che lasciano in bocca, il desiderio di qualcosa che è sfuggito di mano. La nostalgia di un eden che potrebbe realizzarsi e che invece diventa polvere di parole. L’impressione a volte è che Onofrio si trovi in mezzo a quel meraviglioso guado che sta tra la letteratura d’impegno e quella sperimentale. Un fatto assolutamente nuovo nel panorama italiano che o ha visto giocare senza finalità gli scrittori in giochi linguistici di prestigio per la ghiottoneria dei filologi, o li ha visti grondare di posizioni ideologiche che non portavano la narrativa da nessuna parte. Perché l’arte non sopporta i padroni e le imposizioni, e vive in maniera anarchica le sue libagioni di vita, di sogni e di morte. Ecco, le libagioni di Marco Onofrio sono fatte di queste sostanze; egli le nutre con il suo entusiasmo, con il suo vigore, con le sue contraddizioni, con i suoi umori che si muovono circolarmente andando in cerca dell’Aleph. Tuttavia non è narratore metafisico tout court: ne sfiora ogni tanto le ruote acuminate e scardinanti, ma l’abbacinamento, come direbbe Canetti, lo fa avvenire a piccoli passi, con risvolti che hanno la dolcezza e la perentorietà delle rivelazioni. Siamo dinanzi a uno scrittore fecondo e inverecondo, casto e impudico, avido di conoscenze continue, disposto a mettersi in gioco di volta in volta, mai pago di ciò che raggiunge. È come se fosse dentro un orizzonte che si sposta di continuo, dentro tracce che subito s’allargano e si dipanano in strade piene di insidie e di meravigliosi e meravigliati imprevedibili. Perciò la narrativa di Marco Onofrio può risultare perfino ispida e scomoda, perché non bada a salvaguardare il lettore e ad accarezzarlo, ma bada a porlo dinanzi alle sue responsabilità di uomo e di cittadino, a scandagliarne la sussistenza umana, la portata dello stupore. Non ce ne sono molti di scrittori così pregni e così combattivi, così scandalosamente casti, così decisi a rompere le barriere dell’assuefazione. Sono alle spalle i Baricco, le Cardella e le Tamaro, i Brizzi e i Moccia. Speriamo che anche in Italia finalmente il racconto trovi, anzi ritrovi, l’attenzione necessaria e meritata. Anton Čechov diceva che un racconto riuscito è un anello di diamanti infilato perfettamente nell’anulare di una fata.

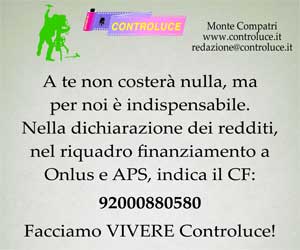



-ban.jpg)















































































































































































Non ci sono commenti, vuoi farlo tu?
Scrivi un commento