La roba rubata!
 Diceva bene Giovanni Verga, quando sosteneva che i Siciliani sono legati alla loro roba. Suo figlio Pietro, infatti, ha dedicato più di vent’anni per poter riscattare la roba di suo padre. Si tratta di manoscritti, lettere, disegni, appunti, ritrovati oggi, dopo ottant’anni. Sono stati recuperati tra Pavia e Roma dai carabinieri dei beni culturali. Pietro li ha cercati dal 1957 al 1977 e, nel 1975, ottenne dal Tribunale di Catania il possesso legale di tutti i manoscritti di famiglia.
Diceva bene Giovanni Verga, quando sosteneva che i Siciliani sono legati alla loro roba. Suo figlio Pietro, infatti, ha dedicato più di vent’anni per poter riscattare la roba di suo padre. Si tratta di manoscritti, lettere, disegni, appunti, ritrovati oggi, dopo ottant’anni. Sono stati recuperati tra Pavia e Roma dai carabinieri dei beni culturali. Pietro li ha cercati dal 1957 al 1977 e, nel 1975, ottenne dal Tribunale di Catania il possesso legale di tutti i manoscritti di famiglia.
Fu proprio il figlio che affidò i manoscritti ad uno studioso di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) con l’intento di dare un ulteriore contributo alla cultura, perdendone poi le tracce fino ad oggi. Il ritrovamento e l’accusa di appropriazione indebita nei confronti di una donna romana – A. P. di 76 anni – è avvenuto a seguito di una vendita all’asta nel dicembre 2012 a Pavia che ha incuriosito la Soprintendenza ai Beni Librari della Regione Lombardia. Hanno avuto inizio, così, le indagini guidate dalla Procura della Repubblica di Roma e affidate al reparto operativo dei carabinieri dei beni culturali, con a capo il maggiore Antonio Coppola. In questo momento i documenti si trovano custoditi al Fondo manoscritti Maria Corti, presso L’Università degli studi di Pavia, dove sarà valutata l’esatta consistenza e il completo recupero. Come insegna Verga nei Malavoglia, i Siciliani sono molto legati alle loro cose, che chiamano “roba”, e la ricerca è proseguita per ottant’anni; si parla di un fondo stimato 4 milioni di euro. Un prezzo approssimativo per opere che hanno un valore inestimabile. Un furto alla famiglia Verga, alla città di Catania e a tutti noi, perché ci sono stati nascosti tasselli importanti per ricostruire il profilo di uno degli esponenti principali del Verismo italiano. Per adesso sappiamo che si tratta della prima stesura de I Malavoglia, la bozza di Mastro don Gesualdo, de La Lupa, de I carbonari della montagna, le corrispondenze con Gabriele D’Annunzio, Luigi Pirandello, Benedetto Croce e la prima stesura del romanzo Amore e Patria, scritto all’età di soli sedici anni, ormai ritenuto disperso.  Squarci del passato, la cui lettura ci permettere di rivivere quei momenti assaporandone le amarezze, i problemi esistenziali vissuti con dignità, superati con la forza e sostenuti da famiglie unite, esempi ormai in disuso nella nostra società. Un apporto anche all’economia, perché Verga non ha taciuto il suo giudizio negativo sulla società umana degli anni tra 1870-1880 in cui si stava sviluppando l’economia capitalistica e con l’industrializzazione che stava trasformando i paesi agricoli in centri moderni. Non ha taciuto il grido della società contadina legata alla propria terra, “roba”, lasciandoci una testimonianza di sfruttamenti e ingiustizie. Vite narrate per essere ricordate e per elevarle ad “egreggie azioni”, come direbbe Foscolo. Episodi di vita che servono da riflessione e che si avvicinano molto alla società dei nostri giorni, colpita dalla crisi. Un furto inestimabile, quindi, che ha impoverito, anche se temporaneamente, la cultura di tutto il mondo. Un ritrovamento che ha rivendicato la famiglia Verga e che ci ricorda che tutti noi abbiamo formato la nostra cultura sulle opere di grandi maestri. Verga ci ha permesso di essere trasportati nella sua quotidianità attraverso la lettura delle sue opere e ci ha insegnato molto, dal valore della famiglia ai diritti umani e lavorativi e, anche con un velo di drammatica romanticità, che non viviamo solo di pane e acqua, ma d’amore: «Avevo visto una povera capinera chiusa in gabbia: era timida, triste, malaticcia; ci guardava con occhio spaventato; si rifugiava in un angolo della sua gabbia, e allorché udiva il canto allegro degli altri uccelletti che cinguettavano sul verde del prato o nell’azzurro del cielo, li seguiva con uno sguardo che avrebbe potuto dirsi pieno di lagrime. Ma non osava ribellarsi, non osava tentare di rompere il fil di ferro che la teneva carcerata, la povera prigioniera. Eppure i suoi custodi le volevano bene, cari bambini che si trastullavano col suo dolore e le pagavano la sua malinconia con micche di pane e con parole gentili. La povera capinera cercava di rassegnarsi, la meschinella; non era cattiva; non voleva rimproverarli neanche col suo dolore, poiché tentava di beccare tristemente quel miglio e quelle micche di pane; ma non poteva inghiottirle. Dopo due giorni chinò la testa sotto l’ala e l’indomani fu trovata stecchita nella sua prigione. Era morta, povera capinera! Eppure il suo scodellino era pieno. Era morta perché in quel corpicino c’era qualche cosa che non si nutriva soltanto di miglio, e che soffriva qualcosa oltre la fame e la sete». (da Storia di una capinera).
Squarci del passato, la cui lettura ci permettere di rivivere quei momenti assaporandone le amarezze, i problemi esistenziali vissuti con dignità, superati con la forza e sostenuti da famiglie unite, esempi ormai in disuso nella nostra società. Un apporto anche all’economia, perché Verga non ha taciuto il suo giudizio negativo sulla società umana degli anni tra 1870-1880 in cui si stava sviluppando l’economia capitalistica e con l’industrializzazione che stava trasformando i paesi agricoli in centri moderni. Non ha taciuto il grido della società contadina legata alla propria terra, “roba”, lasciandoci una testimonianza di sfruttamenti e ingiustizie. Vite narrate per essere ricordate e per elevarle ad “egreggie azioni”, come direbbe Foscolo. Episodi di vita che servono da riflessione e che si avvicinano molto alla società dei nostri giorni, colpita dalla crisi. Un furto inestimabile, quindi, che ha impoverito, anche se temporaneamente, la cultura di tutto il mondo. Un ritrovamento che ha rivendicato la famiglia Verga e che ci ricorda che tutti noi abbiamo formato la nostra cultura sulle opere di grandi maestri. Verga ci ha permesso di essere trasportati nella sua quotidianità attraverso la lettura delle sue opere e ci ha insegnato molto, dal valore della famiglia ai diritti umani e lavorativi e, anche con un velo di drammatica romanticità, che non viviamo solo di pane e acqua, ma d’amore: «Avevo visto una povera capinera chiusa in gabbia: era timida, triste, malaticcia; ci guardava con occhio spaventato; si rifugiava in un angolo della sua gabbia, e allorché udiva il canto allegro degli altri uccelletti che cinguettavano sul verde del prato o nell’azzurro del cielo, li seguiva con uno sguardo che avrebbe potuto dirsi pieno di lagrime. Ma non osava ribellarsi, non osava tentare di rompere il fil di ferro che la teneva carcerata, la povera prigioniera. Eppure i suoi custodi le volevano bene, cari bambini che si trastullavano col suo dolore e le pagavano la sua malinconia con micche di pane e con parole gentili. La povera capinera cercava di rassegnarsi, la meschinella; non era cattiva; non voleva rimproverarli neanche col suo dolore, poiché tentava di beccare tristemente quel miglio e quelle micche di pane; ma non poteva inghiottirle. Dopo due giorni chinò la testa sotto l’ala e l’indomani fu trovata stecchita nella sua prigione. Era morta, povera capinera! Eppure il suo scodellino era pieno. Era morta perché in quel corpicino c’era qualche cosa che non si nutriva soltanto di miglio, e che soffriva qualcosa oltre la fame e la sete». (da Storia di una capinera).

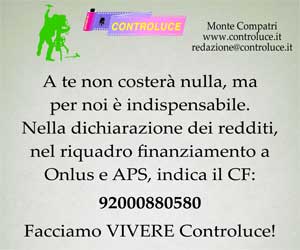



-ban.jpg)















































































































































































Non ci sono commenti, vuoi farlo tu?
Scrivi un commento