Ingeborg Bachmann e Roma – IV
Roma non è preservata dall'”odore di sporcizia e decomposizione”, come la “puzza di pesce, cloro e frutta marcita” che resta dopo la chiusura dei mercati (1). Una città concreta, corporea, incrostata, ma intensamente viva, umana, intrisa di “presenza”. Basta poi un soffio a “riscattarla”. Una sorpresa, provvida e misteriosa, che può risplendere dietro l’angolo, da un momento all’altro. E all’improvviso diventa la più bella. Come il suo cielo.
Ho visto dove le strade di Roma finiscono, insinuarsi in città il cielo trionfante, che non si chinava sotto nessun portone e si estendeva sopra i sette colli, azzurro dopo le scorrerie sulle coste della Sicilia e pieno dei frutti delle isole del mar Tirreno, illeso dopo gli assalti nel paese dei briganti d’Abruzzo e nero di grappoli di rondini, salvo sopra l’Appennino. Ho visto il lodato cielo di ermellino e il cielo misero di tela di sacco, e ho visto nei suoi momenti migliori la sua mano tracciare la sezione aurea sopra i tetti (2).
O come il suo scirocco, quando vince
sul vento aquilone delle montagne (…) È il tempo in cui aumentano le disgrazie ed è facile pronunciar parole senza amore. Perché il vento caldo ci ricaccia nel deserto. A volte lo fa sapere, sparge sabbia rossa sulla città infiacchita e ci soffia sopra fino a lasciarla priva di sensi. Quando lo scirocco se ne fa, lo fa in segreto e durante la notte, mentre noi dormiamo smemorati. Ma al mattino, verso le tre, cade la rugiada. Se si potesse giacere lì svegli e inumidirsene le labbra! (3)
La trasfigurazione letteraria della città riecheggia anche nel racconto eponimo della silloge Il trentesimo anno (1961). Ma il disincanto è cresciuto, e Roma non regala più folgorazioni epifaniche. Tutto è più cupo, lontano, irreversibile. Il protagonista avverte il richiamo della città che lo ha reso libero come mai nella vita: la città dove ha potuto raccogliere, come gocce di rugiada, la freschezza vergine dei nomi e la profonda verità delle parole.
L’inquietudine lo assale. Sente il bisogno di fare le valigie, di lasciare la sua camera, di allontanarsi dal suo ambiente e dal suo passato. Non gli basta partire per un viaggio, deve proprio andarsene. In quell’anno deve sentirsi libero, lasciare tutto, cambiare luogo, abitazione e persone. Deve saldare i vecchi conti (…) Così potrà staccarsi da tutto, liberarsi di tutto. Deve andare a Roma, ritornare laggiù dov’era stato libero come non mai, dove anni prima aveva conosciuto il suo risveglio, il risveglio dei suoi occhi, della sua gioia, dei suoi princìpi, della sua morale (4).
Ma non è più così.
Appena giunto a Roma, s’imbatte nell’immagine di sé che un tempo aveva lasciato negli altri. Essa gli viene imposta come una camicia di forza. S’infuria, si difende, si dibatte finché capisce e si placa. Non gli è concessa alcuna libertà perché, in passato e quand’era più giovane, in quel luogo s’era permesso di essere diverso. Mai più in nessun luogo riuscirà a sentirsi libero, a ricominciare da capo (5).
Ed ecco, lapidario come una sentenza, il segno di uno scacco irreversibile:
Roma è grande. Roma è bella. Ma tornare a viverci è impossibile (6).
(continua)
———————
(1) I. Bachmann, Quel che ho visto e udito a Roma, Macerata, 2002, p. 120.
(2) Ivi, p. 121.
(3) Ivi, p. 124.
(4) Id., Il trentesimo anno, Milano, 1990, p. 26.
(5) Ivi, p. 27.
(6) Ivi, p. 29.

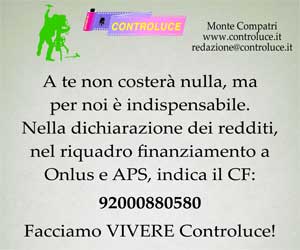



-ban.jpg)















































































































































































Non ci sono commenti, vuoi farlo tu?
Scrivi un commento