Covid-19. Un viaggio con ritorno per uno sguardo nuovo

Poi ti svegli una mattina e sai che ti ha colpito. Poche linee di febbre, qualche colpo di tosse secca, spossatezza e respiro corto, e l’allarme scatta ma fingi di non sapere. Da mesi vivi in stato di assedio, da quel primo blocco totale decretato nel marzo 2020 ‒ appena passato il Carnevale ed entrati con le Ceneri in periodo di Quaresima ‒ e da buon cittadino, oltre che rispettare le normative imposte di volta in volta contro l’assalto del neo Coronavirus, fra giravolte da capogiro, ti sei premurato di far riscorso a tutto il buon senso comune per evitare possibili contagi di cui tutti, per quanto è dato sapere al momento, potremmo essere portatori o ricettori, e dovresti pertanto sentirti tranquillo ma non lo sei affatto.
Per un paio di giorni fingi di stare bene, ti dici che è tempo di influenza e ancora non hai fatto il vaccino, esaurite le prime scorte si attendono rifornimenti. Vabbè aspettiamo, e intanto metti in atto il fai da te per combattere i sintomi che persistono, come si trattasse di un malanno di stagione.
Poi un sera non riesci ad addormentarti perché sai che stai barando e al mattino lasci la chiamata al tuo medico di base. Che per tua fortuna è un bravissimo medico e se pure oberato e logorato da un lavoro da troppo tempo sopra le forze umane, ti richiama appena possibile, ti ascolta, ti fa alcune domande, ti prescrive intanto un antibiotico ad ampio spettro, utile se non altro per escludere infezioni batteriche, e ti dice che fa subito richiesta di tampone a domicilio per il Covid-19 e non serve che ti raccomandi l’isolamento.
Passa una settimana e aspetti ancora l’arrivo di un operatore sanitario che ti venga a fare il prelievo per il tampone, intanto ti pare di sentirti meglio e temporeggi ma fortunatamente il tuo medico non ci dorme sopra, e al settimo giorno ti chiama al telefono per notizie e saputo che nessuno si è fatto vivo da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) della ASL Roma 6, come da lui formalmente richiesto, ti dice che il mattino dopo, urgentemente, devi fare il 118 e chiamare un’ambulanza.
Fai mente locale e ti prepari il necessario. Confusione totale, siamo a mezza stagione, infili di tutto un po’ dentro il borsone, un sacchetto con i farmaci abituali per patologie croniche, il vecchio cellulare e caricabatterie, una bottiglia d’acqua, metti le scarpe e dimentichi le pantofole.
Sei pronto. Silenziosa arriva l’ambulanza, ultima generazione, e ne scendono due angeliche figure che ti vengono incontro sulla porta di casa. Ti pongono qualche domanda e dalla voce rincuorante, dallo sguardo limpido che cerca il tuo dal fondo di tutto quel biancore, sai che sono qui per aiutarti. Arrivano da un comune della provincia di Latina. Dalle tue parti, ai Castelli Romani, non c’è possibilità di ricovero, i vari ospedali, da sempre ottimamente funzionali, sistematicamente smantellati a favore di un megaprogetto muffito e realizzato in parte e malamente; al Tor Vergata di Roma il tutto esaurito, resta il Santa Maria Goretti di Latina a circa trenta chilometri dalla tua residenza. Pazienti, i giovani soccorritori non ti mettono fretta, ma sai che devi decidere e presto. Telefoni al tuo medico per chiedere il suo parere, e si dice assolutamente favorevole: benissimo per l’ospedale di Latina. Prendi la tua roba e salti su, lasciandoti alle spalle il sorriso forzato dei familiari che ti salutano con la mano.
Ti stendi sulla lettiga nel vano attrezzatissimo, strumentazioni all’avanguardia, ago nel braccio, e si parte. Un viaggio breve che ti porta lontano, in zona incognita.
Ti trovi in fila per lo smistamento, guidati da un robusto operatore lungo il percorso per pazienti con sospetto Covid-19. In una stanza con un solo bagno ti aspetta una lettiga ai piedi di quattro lettini occupati. Ti stendi e ti copri col tuo giaccone, è fine ottobre e comincia a fare freddo. Forse ‒ pensi ‒ dovevi portarti una coperta. Anche i tuoi compagni di stanza, età variabile fra cui anche un giovane, si arrangiano per coprirsi con i loro indumenti. Alcuni di loro utilizzano a tratti il respiratore, ma non sembrano molto sofferenti.
La giornata passa lenta, ti rincantucci e pensi. Acqua contata e niente pasti, addenti il mezzo panino che una infermiera benevola verso sera va distribuendo, mentre alcune porzioni di carote lesse le sono state strappate dalle mani appena entrata. La notte scorre nera tra i respiri graffianti e il ronfare intermittente, e l’andirivieni al bagno che ti sta proprio accanto vanifica ogni tentativo di appisolarti. Pazienza, per dormire ci sarà tempo.
Il mattino dopo si aggiunge una lettiga arriva una ragazza. Racconta della nottata passata in ambulanza, in coda al Pronto Soccorso. In poche ore la situazione è precipitata, ospedali saturi, difficile trovare un posto letto anche fuori comune di residenza. M’è andata bene ‒ tu pensi ‒ a momenti incappavo nell’ingorgo.
Arrivano conforti da casa, pacchi che i familiari consegnano al gruppo di volontari che si occupano di farteli recapitare dopo averli chiusi nei bustoni neri di plastica col tuo nome scritto sopra. Ti viene da piangere mentre afferri un succo di frutta e offri in giro merendine e bibite, accettate o rifiutate con un sorriso. Ci si sente affratellati nel bisogno, nell’incertezza della comune condizione.
Più tardi passano per i controlli e rilevamento dati e iniziano i prelievi, doloroso e delicato quello venoso e ti avvisano affinché non scalci. Abilità e competenza ma anche gentilezza del personale infermieristico ti rassicurano, sei in buone mani.
Il giorno seguente passi dalla zona d’osservazione al Pronto Soccorso. Un vasto semicerchio di lettighe occupate dalla varia umanità, composta perlopiù di soggetti stagionati di cui anche tu fai parte, ma anche di alcuni giovani e adulti e ciò ti addolora, ti spaventa, e dirimpetto il lungo tavolo operativo e un gran movimento di personale medico sotto la supervisione del responsabile di turno. E pensi che in questo tipo di guerra virale c’è di buono che ci si aggrega per salvare vite e non si combutta invece per mandarle al macello.
Tocca a te. Tampone, TAC al torace, risultati rapidi, e via di corsa al reparto isolamento. Sei in carrozzina spinta da un’energica infermiera che lungo tutto il percorso centrale, a senso unico in area sanificata, continua a urlare “Tutti dentro!” e al tuo apparire si fa il vuoto e lo sbattere precipitoso delle porte laterali ti dà la misura della pericolosità che rappresenti, affetto da Covid-19 nella sua forma più grave e contagiosa.
Uno stanzone e bagno con doccia, un tavolo, due finestroni a vetri che spandono luce, un lettino regolabile, e una porta che si chiude alle tue spalle con l’ordine di non aprirla per alcun motivo: in caso di urgenza premere il pulsante per la chiamata. L’isolamento dopo tanto affollamento lo vivi come un ristoro, pensi di fare una doccia ma rinunci perché non stai in piedi, ti stendi e guardi il cielo scorrere dietro la vetrata. Da questo momento vedrai solo tute bianche striate d’azzurro e mani guantate del personale medico, e fuggevolmente camici monouso all’ora dei pasti che ti arriveranno in contenitori sigillati chiusi in una busta di plastica, lanciata a volte sul tavolo dalla porta appena socchiusa.
Inizia la terapia. Non fai domande, non ne hai mai fatte da quando sei arrivato in ospedale, forse preferisci non sapere, non tenerti aggrappato allo scorrere delle ore e dei giorni, all’andamento dell’infezione e alle risposte del tuo organismo già molto indebolito.
La prima notte avanza snervante, pensavi di dormire come un sasso dopo tanta veglia ma non riesci a chiudere occhio. Il gelo ti acchiappa nella sua morsa verso l’alba e sembra eterno, ti contorci battendo i denti scosso dai brividi.
Forse lo spiffero della finestra semiaperta ‒ pensi ‒ ma ti sbagli: sono gli effetti della massiccia terapia associata e tu sei un campo di battaglia. Il peggio deve venire ma non ti curi di anticiparlo, ti basta succhiare aria per un respiro alla volta.
Da casa ti arriva una coperta di lana pura di quelle che non si trovano più, consegnata dai volontari nel bustone nero, e abbozzolato nel soffice tepore raccogli le tue forze e ti opponi al male. Non sei solo, nell’isolamento. C’è tutta la tua vita e quella delle vite che hai incrociato vivendo. Ci sono i tuoi affetti stretti e l’affezione per l’intera umanità e la Casa stupenda che tutti ospita, c’è la gratitudine immensa per chi ti sta attorno e rischia di suo per proteggerti, e per tutti coloro impegnati a fondo, in ogni campo, per trovare rimedi contro una forza distruttiva altamente organizzata.
Si chiude una porta alle tue spalle ‒ non sarai più quello di prima, ammesso che tu ce la faccia a superare le prove che ti aspettano ‒ e mentre il tuo corpo si dissecca e geme si solleva un sipario su un mondo altro, niente affatto nuovo ma troppo spesso in ombra: la forza dei giovani, la bellezza del loro sguardo diritto, la gentilezza del loro animo integro, la fiducia e l’entusiasmo che trasmettono con ogni loro gesto, la preparazione e la responsabilità di cui largamente dispongono, la partecipazione emotiva con cui rafforzano le tue difese.
No, non sarai più quello di prima, dopo un mese di sofferenze ed esperienze traumatizzanti dovute in parte a un sistema lacunoso e contraddittorio, ma se ti dice bene e reggi al cedimento in agguato, potrai forse acquisire uno sguardo nuovo rispetto al mondo e al vivere, uno sguardo disincantato ma vero, capace di cogliere la scintilla di bene anche nell’avvampare di malefici miasmi. Capace di apprezzare, nel bene e nel male, l’istante che ci è dato vivere, sia pure a caro prezzo.

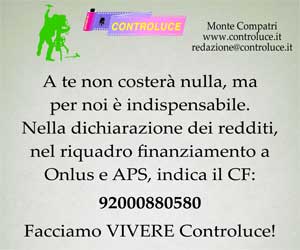



-ban.jpg)















































































































































































Grazie Rita, grazie Armando.
È la vita che c’insegna, con il suo bene e il suo male, inscindibili. poco resta da dire di fronte al disastro immane a cui si sta assistendo e che non risparmia niente e nessuno, che si ricavi almeno da una tale durissima lezione la consapevolezza che nessuno si salva da solo.
Sai essere te stessa sempre, anche in momenti non facili… una grande maestra di vita. Un abbraccio forte cara Maria.
Rita
Carissima Maria,
hai costruito una cronaca sugli eventi che ti hanno coinvolto negli ultimi mesi che non contiene ira, risentimento verso nessuno (neanche per colui o coloro che ti hanno contagiato). Hai mantenuto la tua capacità di osservazione ironica anche all’interno di un dramma fisico e psicologico e hai chiuso con un messaggio d’amore verso l’umanità e verso la natura.
Il coinvolgimento e la commozione, comunque, mi hanno accompagnato continuamente nel corso della lettura.
Ti abbraccio