“C’era una volta in Anatolia”
 Nel cuore dell’Anatolia, paesaggio arido e brullo, è notte fonda. Una squadra di poliziotti percorre in macchina le strade deserte, con loro viaggia un presunto assassino. Sono alla ricerca del corpo di un uomo ammazzato. Nuri Bilge Ceylan racconta la sua terra turca, la sua gente, una cultura, la sua, che il buio della notte copre, ammanta come a nascondere la miseria della vita, della gente, delle cose della quotidianità.
Nel cuore dell’Anatolia, paesaggio arido e brullo, è notte fonda. Una squadra di poliziotti percorre in macchina le strade deserte, con loro viaggia un presunto assassino. Sono alla ricerca del corpo di un uomo ammazzato. Nuri Bilge Ceylan racconta la sua terra turca, la sua gente, una cultura, la sua, che il buio della notte copre, ammanta come a nascondere la miseria della vita, della gente, delle cose della quotidianità.
Il commissario Naci, il procuratore Nusret, il dottor Cemal, l’autista Arab Ali e il sospettato dell’assassinio, Kenan si muovono da un posto all’altro, cercano un albero tondo dove dovrebbe essere sepolto il corpo. Un viaggio che condurrà i protagonisti a ribaltare quello spazio esterno che li vede indagatori di un crimine, a specchio impietoso della propria esistenza, dei propri limiti e di miserie esistenziali. Il film sviluppa la storia lentamente sin dall’inizio, di notte, girovagando con le macchine in mezzo alla steppa, al gelo. E in tutto questo girovagare i dialoghi dei protagonisti affascinano, conquistano per la naturalezza dei contenuti spontanei, che ordinano la trama e la definiscono passo dopo passo, mentre i volti degli uomini che parlano sono illuminati da un deciso chiarore lunare. Dai dialoghi emergono battute ironiche, sapori e odori, come la bontà dello yogurt o dell’agnello alla griglia, che allontanano sapientemente ansie e sospetti di una ricerca che durerà tutta la notte, fino alle prime luci del mattino. Perché C’era una volta in Anatolia è un messaggio possente e nello stesso tempo affascinante? Perché Nuri Bilge Ceylan sviluppa una rete di sentimenti ed emozioni, li filtra attraverso i volti dei personaggi, costruisce e porge allo spettatore con magistrale naturalezza i caratteri ben delineati di uomini dimessi e desolati, espressioni di una cultura chiusa, soggiogati da un destino comune. I dialoghi strutturano un senso, le parole rendono con le idee, le affermazioni, le domande, gli aspetti interiori dei protagonisti. La malinconia è la compagna di ognuno di questi uomini. Il procuratore Nusret, ironicamente afferma che il volto del morto somiglia a Clark Gable, ma si addossa la responsabilità del suicidio della moglie. Il dottor Cemal, dal volto plumbeo, scioglie la sua lingua verso la fine del film e nega, senza convinzione con un secco no, che il morto ammazzato sia stato sotterrato vivo. Alle figure femminili Nuri Bilge Ceylan restituisce una dignità composta, sofferta nel proprio ruolo, com’è per la moglie dell’uomo ammazzato, dallo sguardo accusatore, una consapevolezza d’impotenza, un’accettazione di un fatto accaduto, una perdita ormai irrimediabile. Il cinema di Nuri Bilge Ceylan apre al confronto, alla relazione per la specificità dei contenuti narrati, per la veridicità della rappresentazione dei luoghi e la concettualizzazione dei personaggi collocati nelle loro particolari relazioni spazio-temporali. C’era una volta in Anatolia ne è una valida dimostrazione, così come è stato per il film Le tre scimmie. Siamo in pieno cinema interculturale, caratterizzato da un considerevole grado di reciprocità grazie ad un processo mediatico rappresentativo di un’altra cultura, come è in questo specifico contesto filmico la cultura turca. Il cinema di Bilge Ceylan indaga e racconta le abitudini e le vicende della sua gente, con una polifonia di codici che caratterizzano la singolarità della sua narrazione cinematografica, che permette l’immedesimazione con i protagonisti delle vicende. Premiato al Festival di Cannes 2011, C’era una volta in Anatolia è un documento culturale, un validissimo messaggio per un pubblico che, fruendo mediaticamente la cultura dell’altro, comunque rimane nella consapevolezza della distanza che esiste tra film e realtà.

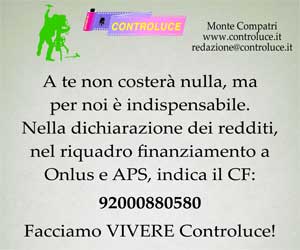



-ban.jpg)















































































































































































Non ci sono commenti, vuoi farlo tu?
Scrivi un commento