Camicia Rossa, Giubba Blu – 1/2
 È l’inizio di novembre dell’anno di grazia 1867. Giovanni è stanco, infreddolito, con solo un pastrano leggero a coprire quella camicia rossa che tanto ha sognato, desiderato e amato. Ma a quindici anni i sogni scaldano il cuore, e la sagoma di Garibaldi che passa a cavallo tra i suoi dà una scarica di euforia che ti fa passare la fame e il freddo umido delle notti di inizio novembre a Monterotondo. Il morale però non è alle stelle: l’insurrezione di Roma non c’è stata, e l’invasione del Lazio da parte di quel piccolo esercito di ottomila garibaldini è ormai fallita. Ci si sta ritirando verso Tivoli, dove il Generale vuole sciogliere la legione garibaldina, ormai minata da molte defezioni. Giovanni stringe il suo vecchio moschetto a pietra focaia in una mano, ma nell’altra tiene la sua vera arma di offesa: una tromba di ottone lucente con cui sparare nei cuori del nemico il terrore della carica ‘alla garibaldina’, baionetta innestata, gambe al vento, e furibondo corpo a corpo.
È l’inizio di novembre dell’anno di grazia 1867. Giovanni è stanco, infreddolito, con solo un pastrano leggero a coprire quella camicia rossa che tanto ha sognato, desiderato e amato. Ma a quindici anni i sogni scaldano il cuore, e la sagoma di Garibaldi che passa a cavallo tra i suoi dà una scarica di euforia che ti fa passare la fame e il freddo umido delle notti di inizio novembre a Monterotondo. Il morale però non è alle stelle: l’insurrezione di Roma non c’è stata, e l’invasione del Lazio da parte di quel piccolo esercito di ottomila garibaldini è ormai fallita. Ci si sta ritirando verso Tivoli, dove il Generale vuole sciogliere la legione garibaldina, ormai minata da molte defezioni. Giovanni stringe il suo vecchio moschetto a pietra focaia in una mano, ma nell’altra tiene la sua vera arma di offesa: una tromba di ottone lucente con cui sparare nei cuori del nemico il terrore della carica ‘alla garibaldina’, baionetta innestata, gambe al vento, e furibondo corpo a corpo.
Così è andata a Bezzecca l’anno prima, durante la III guerra di indipendenza del 1866, quando il Corpo Volontari Italiani accorso in Trentino, sotto una grandinata di proiettili di artiglieria austriaca si era dovuto ritirare dal paese perdendo 500 uomini catturati dal nemico. Giovanni aveva visto il Generale arrivare in carrozza e finire travolto da un tiro incrociato austriaco, la carrozza rivoltarsi, il Giannini, la sua guida, lasciarci la pelle, lo stesso Garibaldi sottratto a braccia dalla carrozza e portato in salvo. Ma allora il Generale aveva sfoderato gli artigli, e dopo un nutrito bombardamento sul centro di Bezzecca, aveva ordinato la carica alla baionetta e lui, con tutto il fiato che aveva in corpo un quattordicenne, aveva sparato le sue note appuntite contro quei maledetti bastardi di Austriaci, spingendo un mare di camicie rosse a conquistare il paesetto e la vittoria. «Viva l’Italia, viva la Libertà.» E adesso invece, solo un anno dopo, si stanno ritirando davanti all’esercito Papalino e ai Francesi, sconfitti più dalla disillusione di un’insurrezione mancata che da un esercito nemico, presi in mezzo tra gli Zuavi Pontifici che risalivano verso Monterotondo e i Dragoni e i Francesi dalla parte di Mentana, che gli tagliavano la via di fuga di Tivoli. Le scaramucce e gli scontri durarono tutto il giorno. Poi calò la sera. Giovanni è acquattato nella sua postazione con la sua tromba stretta nel pugno, stanco come un quindicenne può esserlo; tra il sonno e la veglia, rivede una piazza assolata di paese, una folla di gente festante, e la sagoma enorme di un uomo biondo che avanza avvolto in uno strano camicione, contornato da camicie rosse e bandiere tricolori. È il 1860 e a Sala Consilina, il suo paese, sta transitando l’esercito vittorioso di Garibaldi che risale la penisola per conquistare Napoli. Giovanni Crisostomo Martini è un moccioso di otto anni, vestito di stracci come quasi tutti i suoi coetanei. Tenuto per mano dalla donna che da sempre gli fa da madre, dopo che lo ha raccolto dalla ruota dei Projetti, il luogo dove si abbandonano i neonati lasciati al buon cuore dei passanti, il 28 gennaio 1852. Giuà urla come un ossesso, vuole toccare l’Eroe, sgattaiola tra la folla, gli si avvicina tra le gambe dei garibaldini, gli tira il poncho e gli urla qualcosa. Garibaldi lo sente e si ferma, lo guarda divertito e gli chiede: «E tu cosa vuoi da me, ragazzino?» e Giuà: «Voglio venì co vuie!» – «Ma sei troppo piccolo per sparare» risponde il Generale, e lui testardo: «Ma io nun voglio sparà, voglio suonà la tromba!» Garibaldi lo guarda serio e promette: «Quando sarai più grande, verrai con me!»…. La voce di Garibaldi risuona nelle orecchie di Giovanni. È forte e reale, è voce presente. Non è più un sogno. È il generale che sta ordinando un contrattacco per tentare un accerchiamento sui fianchi dei papalini. Dai, Giovanni, spara le tue note contro il nemico, che bisogna farsi strada a baionettate per sfuggire alla morsa, «Viva l’Italia, Viva la Libertà!». Ma è un fallimento. I Francesi dall’altro fianco attaccano duro, e con i loro fucili Chassepot aprono varchi e sfondano. È la fine di un sogno mai iniziato. Nella notte il Generale decide di ritirarsi verso i confini del Regno d’Italia con i suoi uomini superstiti. E Giovanni è con lui. E pure la sua tromba è con lui. È l’inizio di Novembre dell’anno di grazia 1867.
È il Giugno dell’anno di grazia 1876. John ha la schiena indolenzita, e il sedere gli duole ormai da ore. La sella sembra di ferro, eppure sono solo le prime ore del mattino. Il fazzoletto giallo stringe al collo la camicia blu, il sottogola del cappello irrita il collo, le bretelle di ordinanza segano le spalle, e i guanti lisi che tengono le redini sono ormai un tutt’uno con le mani. Ma il “Generale” ci tiene moltissimo alla disciplina, e non sarebbe contento di vedere un suo uomo con l’uniforme in disordine. Anche se lui, il “Generale”, veste in un modo tutto particolare, e certamente fuori da ogni ordinanza. Adesso è lì davanti a lui, a distanza di rispetto, che cavalca dritto come un fuso, inguainato nella sua morbida giacca di camoscio con le frange, con in testa il suo cappello bianco a falde larghe da sotto il quale sbucano i capelli biondi. Sono quattro giorni che John cavalca a tappe forzate assieme a tutta la colonna perché il “Generale” ha fretta di trovare la sua preda e sbranarla, come un lupo famelico all’inseguimento delle tracce di un cervo sulla neve. Ma qui nel sud-est del Montana di neve non ce n’è. È il 25 giugno 1876, e il sole sta dissolvendo la bruma di prima mattina. Sono partiti dal campo di Yellowstone il 22, hanno proceduto di gran carriera mangiando polvere e fagioli per tre giorni, e finalmente l’odore della preda si è fatto sentire più vicino e più forte di quanto sperassero. John lo sa bene. Il “Generale” punta tutto sulla sorpresa: vuole stringerli dentro una morsa senza permettere vie di fuga, e poi sterminarli tutti tra le loro tende, senza distinzione tra uomini donne e bambini. Lo ha già fatto nel ’68, sul fiume Washita, dove con 700 cavalieri del 7° ha sterminato il villaggio del Capo Caldaia Nera, per dare una lezione a questi musi rossi che non vogliono starsene nelle loro riserve. Del resto, pensa John, questi non sono esseri umani, sono solo selvaggi sanguinari che si oppongono al progresso e alla ferrovia, siano Cheyenne, Apache, o come diavolo si fanno chiamare. Lui, il “Generale” sa il fatto suo, è uno maledettamente tosto, pronto a buttarsi nella mischia senza paura: una “capa fresca”, avrebbero detto al paese. Come Garibaldi. È diventato Generale di Divisione a soli 26 anni, per meriti acquisiti durante la guerra di Secessione, ma poi, ha dovuto accettare un reintegro nel nuovo esercito degli Stati Uniti col grado di tenente Colonnello. Però per John e per tutta la truppa, quello lì che cavalca in testa a tutti, alto, forte, statuario, coi lunghi capelli biondi che ondeggiano al vento, è sempre e solo il Generale Custer, “il figlio della stella del mattino”, come lo hanno soprannominato gli indiani per la sua abitudine di iniziare i massacri dei villaggi alle prime luci dell’alba. E anche questa volta bisogna arrivare silenziosi e inaspettati per colpire pesante. E vincere. Perché Custer è invincibile. Come Garibaldi. Anche se John ha sentito la storia dello stregone Freccia di Medicina che, durante la firma del trattato di pace con gli sconfitti di Washita River, gli ha fatto cadere un poco di cenere sullo stivale, lanciandogli una maledizione. Ma queste sono cose a cui John non ha mai creduto, neanche quando stava al paese, e la fattucchiera faceva le pozioni e i filtri d’amore. Però è successa una cosa strana: il Generale stamattina in previsione della battaglia imminente si è fatto tagliare i lunghi boccoli biondi, e la cosa desta qualche preoccupazione fra la truppa. Ma nessuno si azzarda a fare commenti espliciti, perché la disciplina è di ferro, e il Generale è temuto da tutti come un dio della guerra. E forse lo è veramente. E adesso lui, John Martin, arrivato da poco in questa terra smisurata e incontenibile, lui che ancora parla poco e male l’americano, che ancora ha difficoltà a comunicare coi compagni Scozzesi, Irlandesi, Francesi, Tedeschi, Polacchi, che per 13 dollari al mese hanno firmato come lui cinque anni di ferma nella Cavalleria degli Stati Uniti, proprio lui l’Italiano, è stato scelto per essere il trombettiere di giornata del Generale. Forse dipende dalle sue note di servizio: altezza 1,68, occhi marroni, capelli neri, carnagione scura, soldato disciplinato e volenteroso. O forse perché riesce a suonare con gran maestria alla tromba l’inno del 7° Cavalleria, il mitico “Garry Owen”, che Custer fa suonare prima di ogni carica di morte, e che il direttore della banda del reggimento, l’Italiano Felice Vinatieri gli ha insegnato così bene. Quanti Italiani ha trovato dal suo arrivo a New York il 1°giugno del 1874. Ma a lui non andava la vita di quella caotica città, non era interessato ai lavori di fatica che gli procuravano i “fratelli” emigrati. Voleva continuare l’avventura da cui proveniva, quando ancora si chiamava Giovanni Crisostomo Martini, da Sala Consilina. E così si arruolò, come tanti, nell’accogliente Cavalleria degli Stati Uniti per 13 dollari al mese, una uniforme senza ricambio, fagioli gallette e carne secca tutti i giorni, e una splendida tromba di ottone luccicante. (continua)

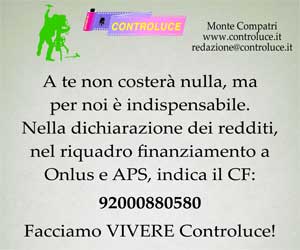



-ban.jpg)















































































































































































Non ci sono commenti, vuoi farlo tu?
Scrivi un commento