Bello, buono e vero
L’Italia è povera di risorse naturali ma possiede il più «grandioso giacimento del Bello, solo in piccola misura valorizzato con il design, la moda, la musealizzazione».
Il suo enorme patrimonio artistico può diventare un bene economico per il Paese? È accettabile che gli italiani abbiano una preparazione artistica che è nella media europea, pur essendo custodi del più grande patrimonio artistico mondiale? Si può da amatori diventare conoscitori di opere d’arte, senza doverle sottoporre ai modelli teorici elaborati dai critici e storici dell’arte con il loro linguaggio ermetico, «più orientato a illustrare teorie estetiche che a una lettura diretta dell’opera»?
A queste e altre domande sul ruolo che l’Arte potrebbe ricoprire nell’ambito dello sviluppo sociale, culturale ed economico del Bel Paese cerca di rispondere, in modo controcorrente rispetto all’establishment del mondo dell’arte, il libro di Piero Trupia Perché è bello ciò che è bello (Milano, FrancoAngeli, 2012). Il desiderio del Bello è sentito da tutti gli uomini, riempie i pensieri e i sogni di ogni uomo ed è il legante universale di tutte le sue molteplici e diverse forme di creatività. Dice il poeta, pittore e filosofo libanese Gibran Kahalil: «Viviamo solo per scoprire nuova bellezza. Tutto il resto è una forma d’attesa». Proprio questo anelito a scoprire nuova bellezza sospinge nei loro cammini, solo apparentemente diversi, tanto l’artista quanto lo scienziato, e anche l’uomo comune nel suo anonimo percorso individuale. C’è un legame molto stretto fra il Bello, il Vero e il Buono. Citerò un esempio che mi sembra molto significativo ed è volutamente attinto non dal mondo dell’arte bensì da quello della scienza: il caso del grande fisico Paul Adrien Maurice Dirac, scopritore dell’antimateria, che fece suo il motto rinascimentale «pulchritudo splendor veritatis», ovvero laddove c’è bellezza c’è verità. Il principio euristico della ricerca scientifica di Dirac era la bellezza: ricercare la verità in fisica per Dirac equivaleva a inseguire la bellezza, che identificava nell’eleganza di un’equazione. Se un’equazione è elegante, prima o poi la teoria fisica che su di essa poggia si rivelerà vera, anche se quell’equazione temporaneamente non riesce a descrivere in maniera soddisfacente la realtà. Questo è proprio è ciò che è accaduto alla famosa equazione di Dirac che prediceva l’esistenza delle antiparticelle molti anni prima che sperimentalmente ne fosse confermata l’esistenza. Le equazioni, per Dirac, sono tanto più eleganti quanto più invarianti offrono, intendendosi per “invarianti” tutte quelle entità o quantità che non cambiano quando si effettuano trasformazioni geometriche (per es. una rotazione) o quando si cambia sistema di riferimento. Quanti più invarianti ci sono in un’equazione, tanto maggiori sono la bellezza della teoria fisica su di essa basata e la possibilità del suo essere vera. Ma perché la bellezza, e quindi l’invarianza, risulta essere garante della verità di una teoria fisica? La risposta è concettualmente semplice: l’invarianza rispetto a una trasformazione (geometrica o di sistema di riferimento) è la prova più convincente dell’esistenza di un oggetto. Una semplice analogia ci può aiutare a capire il senso di questa affermazione. Io posso credere che un oggetto che ho davanti e vedo da una particolare angolazione sia un cubo ma poi, ruotandolo, mi accorgo che non lo è. Se invece, pur cambiando diversi punti di vista, permane in me la vista prospettica di un cubo, mi convincerò che effettivamente quell’oggetto è un cubo. Questo in estrema sintesi il pensiero di Dirac: la bellezza porta all’invarianza e questa alla verità: la bellezza conduce dunque alla verità. Anche l’artista, se la sua opera è valida – dice Trupia nel suo libro – «attinge la claritas, la verità nel suo splendore, secondo l’insuperata definizione della bellezza di Tommaso d’Aquino: Ad pulchritudinem tria requiruntur: […] integritas sive perfectio […] Et debita proportio sive consonantia et iterum claritas».1 All’idea del Bello è pure associata l’idea del Buono, come già Tommaso d’Aquino pose in evidenza nella sua Summa Theologiae. Renzo Piano, nella prefazione al libro di Trupia, dice che l’unica definizione del Bello che gli piace è quella che lo identifica con il Buono inteso come utilitas, e ci ricorda come tale identità fosse presente negli antichi greci e in tutte le lingue africane nelle quali i due concetti costituiscono un’unità inscindibile. Bello e Buono, ovvero sogni e bisogni – dice Piano – «devono camminare sempre uniti». La stessa identità fra Bello e Buono si ritrova nell’esempio di Dirac: la presenza di invarianti in un’equazione è considerata Bellezza per la sua utilitas, in quanto utile per garantire la verità.
Il libro di Trupia tratta in particolare del Bello nell’arte. La prima parte è teoretica ed è quella dove trova ampio terreno d’espressione l’Autore nelle sue vesti di semiologo, filosofo e linguista. La seconda parte, più scorrevole e avvincente, fornisce numerosi interessanti esempi di lettura di celebri quadri ed è quella dove entra in scena l’Autore fattosi da amatore conoscitore d’arte, grazie a quella semeiotica che padroneggia e di cui c’è ampia traccia nella prima parte del libro. Entrambe le parti sono dunque funzionali al conseguimento dell’obiettivo del libro che è – secondo le parole di Santo Versace – «offrire agli italiani uno strumento per riconoscere, comprendere e apprezzare il Bello nell’arte, quale fondamento del Bello nella produzione di qualità», perché – non lo dimentichiamo – «il Bello è la materia prima e, insieme, il risultato finale della produzione made in Italy». Educare a comprendere il Bello, e non soltanto a percepirlo, è quindi importante per noi italiani in particolare, oltre che per scontati motivi culturali, anche per la nostra stessa economia che, non potendo contare su ricche risorse naturali, può invece attingere a quel grandioso giacimento del Bello naturale e artistico, accumulato in millenni di storia grazie alla nostra creatività artistica. Il fine del libro di Trupia è quindi non soltanto culturale ma anche pragmatico: indicare la via per acquisire una piena e corretta capacità di valorizzazione dei nostri tesori d’arte che ci permetta non soltanto di esserne degni custodi ma anche di continuare a produrne, con nuova creatività, e di fruirne come bene economico. Tale meta è raggiungibile facendo crescere i numerosi amatori d’arte dal livello di istintiva attrazione verso l’opera d’arte al livello più cosciente di razionale riflessione sulle ragioni di quell’impatto, divenendo in tal modo conoscitori. L’amatore è «naturalmente orientato all’arte, interessato al suo linguaggio, convinto della sua capacità di comunicare qualcosa di peculiare, non altrimenti esprimibile, sull’Essere, sull’esistenza, sugli esistenti, sul mondo e sul nostro abitarlo». Il conoscitore – prosegue Trupia – «non è necessariamente lo storico dell’arte, l’attribuzionista, l’esperto dell’originalità, dell’autenticità» dell’opera d’arte, ma anche chi soltanto ha acquisito un «gusto tale da potergli suggerire la validità di un’opera, la sua pregnanza di significato e di valore espressivo». Ma come da amatori si diventa conoscitori d’arte? La via maestra è quella anzitutto di considerare l’opera d’arte «una di una», nella sua unicità quindi, prima ancora che «una di molti», nella sua appartenenza a una scuola, a uno stile, a un periodo storico. Trupia, da semiologo qual è, nel suo libro ci dice molto semplicemente come fare: considerare l’opera d’arte nella sua «veste prevalentemente scritturale e testuale», come «scrittura di segni significanti di uno specifico, preciso e semanticamente strutturato linguaggio». Insomma, il conoscitore deve imparare a saper leggere la singola opera d’arte per quello che i suoi segni significanti gli fanno leggere, evitando la forzata applicazione di schemi di lettura precostituiti dai critici d’arte, che spesso hanno l’effetto di una sorta di filtro passa-non passa: se l’opera non rientra nella sagoma teorizzata dalla critica ufficiale si mantiene lo stampo e si elimina l’opera. In tal senso, quindi, se l’opera d’arte è unica, non altrettanto lo è la sua lettura, che è sempre relativa al soggetto ma è molto facilitata da un’educazione in materia di semeiotica, semantica e linguistica testuale.
1 T. d’Aquino, Summa Theologiae, Pars Prima, Quaestio XXXIX, Articulus 8,5.

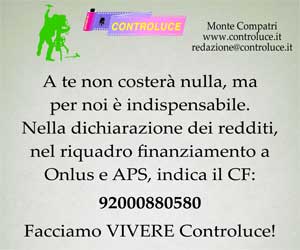



-ban.jpg)















































































































































































Non ci sono commenti, vuoi farlo tu?
Scrivi un commento